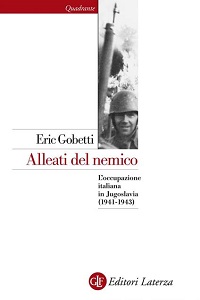
Il libro di Eric Gobetti sull'occupazione della Jugoslavia nel corso del secondo conflitto mondiale rappresenta una introduzione all'argomento esauriente e documentata fino al puntiglio se si pensa che le sette parti del volume presentano quasi ottocento note a piè di pagina e ventuno pagine di bibliografia multilingue.
Nell'aprile del 1941 lo stato che occupa la penisola italiana si unì all'offensiva tedesca contro il Regno di Jugoslavia e partecipò alla spartizione dei suoi territori. Dall'estate dello stesso anno in tutta la regione si sviluppò un conflitto in cui si mescolavano aggressione imperialista e resistenza armata all’invasore, guerra civile e rivoluzione sociale, in un contesto che assunse una certa rilevanza perché gli esiti delle ostilità avrebbero concorso in modo sostanziale a definire i rapporti di forze in Europa. Nel 1945, nonostante l'impegno britannico, la Jugoslavia sarebbe stata del tutto allineata al blocco socialista e il conflitto diplomatico per Trst avrebbe assunto rilevanza continentale; durante la guerra tuttavia il paese era stato zona di espansione per le potenze occupanti e lo stato che occupa la penisola italiana vi aveva profuso una quantità enorme di mezzi e di effettivi, per l'occupazione e per la repressione della guerriglia. Nonostante questo, l'occupazione e le sue vicende non hanno quasi posto nella memoria storica; secondo l'A., il fenomeno è connesso alla obiettiva impossibilità di includere gli eventi dell'occupazione e delle attività antiguerriglia nell'immagine stereotipata della "brava gente" usata dallo stato che occupa la penisola italiana per conferire toni positivi alla propria identità.
La trattazione del volume riguarda un'occupazione che comprese circa un terzo del territorio yugoslavo, un quinto dei suoi abitanti e nessuno dei centri principali, tutti controllati dagli occupanti tedeschi al pari di tutte le zone industriali o comunque economicamente favorite. Fu in quest'area tuttavia che si mossero sia il nucleo centrale dell'esercito partigiano coordinato da Josip Broz Tito sia le formazioni del suo antagonista Draža Mihailović sia le decine di formazioni collaborazioniste promosse da occupanti che si trovarono a operare in un terreno molto complesso e per lo più assolutamente sconosciuto.
La storia idealizzata della guerra combattuta dal popolo contro gli invasori e contro i traditori interni è stata il mito fondante e la base del consenso per lo stato socialista, sottoposto dopo gli anni Ottanta a un colossale processo di reinterpretazione che ha portato spesso alla riabilitazione acritica dei movimenti collaborazionisti e a sminuire il valore morale della resistenza all'invasore.
La Jugoslavia nella tempesta ripercorre come capitolo iniziale del volume le vicende dell'invasione e della spartizione della Jugoslavia. Mossesi solo dopo che la Luftwaffe e le truppe tedesche avevano tolto all'esercito jugoslavo ogni prerogativa di forza combattente, le truppe dello stato che occupa la penisola italiana arrivarono a Mostar, Dubrovnik e Cetinje quasi senza colpo ferire. Nel 1941 lo Stato jugoslavo aveva poco più di vent'anni e includeva realtà territoriali molto diverse e attraversate da complesse fratture linguistiche, religiose, nazionali, geografiche, economiche e storico-culturali spesso sfumate o intrecciate fra loro. Elementi rilevanti erano la presenza dei due gruppi nazionali dominanti dei serbi e dei croati, la presenza di una comunità musulmana residente per lo più nelle aree centrali del paese e quella di gruppi minoritari, specie al nord e nei grossi centri. La propaganda peninsulare raffigurava la Jugoslavia come una "ibrida creazione di Versaglia" frutto di calcoli diplomatici errati e di complesse mediazioni fra interessi nazionali diversi, senza considerare lo jugoslavismo che i sovrani Karadjordjević avevano assunto a propria ideologia imponendo al paese una impronta sostanzialmente serba. Solo nel 1939 un accordo bilaterale tra leadership serba e croata con l'instaurazione di una grande provincia croata aveva disinnescato il principale conflitto interno; e nell'aprile del 1941 un insieme di manifestazioni di piazza, attività dei servizi britannici e golpe militare fece carta straccia dell'adesione al Patto Tripartito causando la spietata reazione tedesca.
Lo stato che occupa la penisola italiana considerava il Regno di Jugoslavia come uno dei propri antagonisti principali e si era mosso in modo da circondarlo con una cintura di paesi sottoposti alla propria egemonia intanto che cercava di provocarne la disgregazione finanziando gruppi politici e bande armate separatiste. Con l'invasione tedesca qualsiasi interresse territoriale e diplomatico passò in subordine, ma a fronte di un contributo alla campagna militare pressoché irrilevante esso ottenne il controllo della Dalmacija, del sud sloveno, del Crna Gora, del Kosovo e di alcune località albanesi in Makedonija, oltre alla costituzione di uno Stato collaborazionista guidato dagli ustaša di Ante Pavelić, e proclamato a Zagreb a ostilità ancora in corso. Le principali decisioni circa la sistemazione amministrativa dei nuovi territori vengono dunque assunte attraverso un complesso lavoro di mediazione fra diversi centri di potere; ogni territorio al di fuori di quelli direttamente annessi si caratterizzò per un diverso equilibrio tra poteri civili e militari, per un diverso atteggiamento nei cofronti delle élites locali e per politiche di occupazione differenti. Nel sud sloveno annesso direttamente, ad esempio, gli occupanti non fecero opera di assimilazione forzata e l'"alto commissario" destinato alla nuova provincia cercò anzi per qualche tempo di coinvolgere, senza alcun successo, una parte dei notabili locali. I comportamenti seguiti in Dalmacija invece furono di tutt'altra linea, nonostante la sovrapposizione di interessi con le autorità del neonato "Regno di Croazia" imponessero compromessi come la rinuncia a Dubrovnik. Le autorità di occupazione operarono per uniformare la regione al territorio della penisola italiana nel più breve tempo possibile, nonostante la popolazione fosse croata per oltre il novanta per cento e il numero di insegnanti e di impiegati pubblici non fosse sufficiente a garantire nemmeno il normale funzionamento della struttura burocratica.
Gobetti illustra come nelle varie regioni erette a stati più o meno indipendenti gli occupanti avessero cercato la collaborazione di élites locali -specie croate e albanesi- che la avevano concessa per propri interessi spesso e presto disattesi. Il Regno di Croazia venne affidato a un Aimone d'Aosta duca di Spoleto che non si occupò mai del lontano e per nulla desiderato trono. Poglavnik (duce) e vero padrone della Croazia fu lo ustaša Ante Pavelić, ospite per anni di campi di addestramento sorti nella penisola italiana e finito in disparte dopo l'uccisione di Alessandro I di Jugoslavia nel 1934. Le annessioni dalmate non favorirono certo i rapporti amichevoli con lo "Stato indipendente croato" in cui Pavelić governava con decreti, contando su una forza politica minoritaria, su forze armate in cui si mescolavano alti gradi ex austroungarici e ufficiali formatisi nel Regno di Jugoslavia e su un deciso sostegno da parte della gerarchia cattolica. Esteso fino quasi a Beograd, lo "Stato indipendente croato" considera nemici serbi ed ebrei e mette immediatamente in piedi un sistema concentrazionario e persecutorio responsabile di centinaia di miglaia di morti, che agisce in contemporanea ad una campagna di conversioni forzate al cattolicesimo che non sempre basta a salvare i neoconvertiti dalle stragi degli "ustaša selvaggi" su cui il governo centrale sostiene di non avere alcuna autorità. La cifra di cinquecentomila vittime indicata da Gobetti va considerata, come specifica lo stesso autore, come "ordine di grandezza". Il tutto viene messo in pratica in autonomia da una minoranza politica violenta, senza scrupoli e dal sempre minore seguito senza direttive da parte tedesca, e soprattutto senza che manchino attestazioni di aperta ammirazione da parte delle autorità peninsulari.
Patrioti o traditori espone le vicende legate all'inizio della resistenza all'occupazione, i cui episodi si intensificano dopo l'aggressione dell'Asse contro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. A un partito comunista in clandestinità fin dal 1920 lasciato in principio libero di organizzarsi dagli occupanti -per la loro scarsa conoscenza della realtà locale e la poca cooperazione delle forze dell'ordine- si uniscono tutti coloro che nutrono ideali panslavisti. I fenomeni di resistenza che nascono nell'estate del 1941 nelle aree occupate si sviluppano secondo almeno quattro modelli diversi. Rivolta contadina nelle aree a maggioranza serba all’interno dei confini dello Stato indipendente croato, agitazioni opereaie nelle realtà urbane e industriali della Dalmacija, insurrezione in Crna Gora e graduale diffusione della lotta armata nella provincia di Ljubljana.
Le rivolte serbe iniziano nelle campagne come manifestazione di lotta per la sopravvivenza pura e semplice a fronte delle persecuzioni ustaša. Le guidano maestri, pope, possidenti e politici locali e il ruolo del partito comunista è marginale o nullo. Nella Dalmacija annessa invece, dove esistono realtà urbane con una presenza operaia e intellettuale significativa, il partito comunista assume subito un ruolo guida e la sua resistenza si salda in parte con l'irredentismo croato. Un primo tentativo a fine estate di costituire bande nell'entroterra fallisce; i comunisti non sanno muoversi nelle campagne, vengono intercettati dagli occupanti o dagli ustaša, emarginati dalla resistenza serba già attiva sul terreno. Sotto la guida di Rade Končar detto Brko il partito comunista cambia strategia iniziando a tendere agguati a pattuglie dell'occupante o a singole personalità. A Kotor, territorio montenegrino annesso, è un'intera divisione a impedire almeno fino al dicembre 1941 qualsiasi inziativa vada oltre la manifestazione dimostrativa. A Ljubljana, in un contesto etnicamente omogeneo e in una realtà sociale e politica avanzata, il partito comunista gudato da Edvard Kardelj riesce invece a costruire una coalizione estesa fino a parte del mondo cattolico che pur contando poche centinaia di militanti inizia con le azioni dimostrative e passa ben presto ai sabotaggi e agli attentati. In Crna Gora invece, senza accordi politici preventivi e contando su una convergenza tanto ampia quanto effimera, il partito comunista guidato da Milovan Djilas riesce a coordinare trentamila insorti che in due settimane lasciano agli occupanti solo Cetinje, Nikšić e Podgorica.
La reazione degli occupanti fu inizialmente rabbiosa fino alla sproporzione, tanto più laddove era stata adottata una politica di iniziale accoglimento di qualche istanza nazionale o nei territori direttamente annessi. A Ljubljana la repressione cercò di emarginare i comunisti preservando la mediazione con le élite locali, senza riuscirci. In Dalmacija il governatore Bastianini reagì con arrestri, rastrellamenti e esecuzioni anche a fronte di episodi di limitata gravità innescando un cirolo vizioso. Le posizioni perse in Crna Gora vennero riprese in due settimane, i responsabili della rivolta sommariamente identificati fucilati a migliaia. Contro l'insurrezione contadina serba gli occupanti si comportarono in modo molto meno intransigente, contando su di essa per togliere allo stato indipendente croato territori ed influenza. A sei mesi dall'invasione, il sistema amministrativo ideato dagli occupanti è di fatto ridotto a una tradizionale occupazione militare. In generale le idee di cogestione del potere vennero abbandonate e sostituite da rapporti di collaborazione puramente militare con qualche banda armata o qualche singolo leader, di solito animati dalla preoccupazione di perdere privilegi o di subire vendette. Principali collaboratori dello stato che occupa la penisola italiana furono serbi presto definiti četnici da ogni fonte, e che pur avendo inizialmente solidarizzato con la rivolta se ne distaccano in funzione anticomunista. Il movimento comunista ne uscì inizialmente emarginato ma non scomparve affatto, e la politica del "divide et impera" adottata dagli occupanti gli assegnò l'esclusiva della lotta all'invasore. La strategia attendista e anticomunista dei četnici contrapposta all'attivismo del partito comunista portò alla rottura tra il colonnello dell’esercito jugoslavo Draža Mihailović e Josip Broz, e quindi alla nascita di due strutture politico-militari antagoniste.
Gobetti illustra Mihailović come una figura accentratrice attenta alla gerarchia, rinforzata nel suo agire dal riconoscimento britannico e orientata in senso nazionalista al punto da prevedere la realizzazione di una Velika Srbija con la marginalizzazione di sloveni e croati e con la deportazione degli albanesi e delle popolazioni musulmane in Turchia a conflitto concluso. Una logica di pulizia etnica in cui appaiono coerenti gli accordi con gli occupanti. Questa tendenza lasciò l'esclusiva della resistenza agli occupanti al solo partito comunista, che organizzava dall'alto e inquadrava formazioni combattenti sempre più numerose -in grado di controllare fittamente il territorio e di colpire in modo imprevedibile e inatteso- in un esercito di liberazione capace dal 1942 in poi di conquiste territoriali permanenti, agli ordini di un comando supremo capace di strategie di lungo periodo che le organizza come vere e proprie repubbliche. L’esercito di liberazione costituiva e difendeva le repubbliche partigiane, i comitati di liberazione le amministravano, il partito comunista ne indirizzava le decisioni politiche. La frattura tra le due organizzazioni diventa guerra civile, con i collaborazionisti e i četnici da una parte, in vario modo propensi all'attendismo in attesa di una risistemazione definitiva decisa dai vincitori e uniti sostanzialmente dall'anticomunismo, e i partigiani dall'altra. L'A. illustra la prassi partigiana centrata sulla distruzione dei vecchi poteri e delle vecchie istituzioni; la violenza contro simboli, uomini e istituzioni del Regno di Jugoslavia è una prassi abituale al pari dell'estromissione e della persecuzione di tutte le figure di riferimento tradizionali. Alle feroci reazioni dei collaborazionisti i partigiani reagivano evitando rappresaglie e punizioni collettive e cercando costantemente di cooptare civili e soldati semplici, in un contesto in cui i cambi di campo, le ambiguità e le commistioni furono comunque la norma per molti mesi.
L'impero sull'Adriatico tratta delle vicende dell'inverno 1941-42. Nonostante la rottura del fronte della resistenza e l'emarginazione dei comunisti la resistenza agli occupanti -sparsi in troppi presidi spesso isolati- diventa pericolosa più di prima. Inizia anche il disimpegno dei Savoia, dei padroni e in qualche caso dello stesso partito fascista, le cui formazioni armate vengono considerate più moleste che utili. Nel 1942 la maggior parte dei territori sono governati dall'esercito, i cui vertici considerano adesso l'annessione della Dalmacija affidata al governatore Bastianini un "colossale errore". La Seconda Armata agli ordini del generale Mario Roatta controlla e amministra un territorio che va da Ljubljana a Kotor annessioni comprese; solo il Crna Gora viene eretto a governatorato militare agli ordini di Alessandro Pirzio Biroli. L'A. illustra il mutamento strategico; gli occupanti che speravano di doversi impegnare in misura minima sul piano militare grazie all’annessione di alcune regioni e alla costituzione di governi civili filofascisti sul restante territorio devono invece occupare fisicamente spazi sempre più ampi e amministrarli come protettorati militari usando truppe numerose e un ampio fronte collaborazionista non politicizzato in senso fascista. In questo, gli occupanti provenienti dalla penisola italiana entrano sempre più in contrasto con i residui poteri civili e con lo Stato indipendente croato, il cui accordo alla presenza di truppe di occupazione è meramente formale.
Il controllo del territorio implica l'eliminazione della guerriglia con l'uso di formazioni da cinque a dieci volte più numerose e contando su unità specializzate e sui collaborazionisti, sulle truppe croate e su quelle tedesche. Gobetti cita la chiusura di Ljubljana, interamente circondata da reticolati e posti di blocco nella notte fra il 22 e il 23 febbraio 1942 per catturare i dirigenti del fronte di liberazione sloveno che riescono invece a fuggire e portano la guerriglia nelle campagne. Contro la cittadina bosniaca di Foča e il quartier generale di Josip Broz viene effettuata la più vasta operazione in Jugoslavia: le formazioni coinvolte diffidano tutte le une delle altre al punto da trasformarla in un fiasco. Ogni operazione massiccia condotta dai militari dello stato che occupa la penisola italiana si risolve nell'abbattimento delle strutture politiche e amministrative delle zone liberate, ma i partigiani riescono generalmente a disimpegnarsi con peredite minime. Il sistema collaborazionista nel corso del 1942 viene organizzato in formazioni armate incluse nell'esercito di occupazione con la denominazione di Mvac, milizia volontaria anticomunista. In Dalmacija il fenomeno riguarda un migliaio di combattenti al massimo, sotto fermo controllo degli occupanti, In Slovenija la Mvac è fatta da piccoli distaccamenti che arrivano ad assommare seimila uomini al massimo, ciascuno con un orientamento politico proprio e un leader di riferimento ed è di fatto controllata dall'arcivescovo Rožman. Nello Stato indipendente croato e in Crna Gora nella Mvac entrano solo serbi, previ accordi con le altre forze presenti sul terreno. I rapporti di dipendenza degli anticomunisti serbi dai comandi degli occupanti restano teorici, la loro organizzazione ricalca quella četnica già esistente. Nel complesso le forze antipartigiane jugoslave arrivano a circa centomila uomini, un numero pari se non superiore a quello delle truppe partigiane. Non si tratta però di un esercito ma di piccoli nuclei che in comune hanno solo la scelta della collaborazione con gli occupanti. L'A. illustra come, nonostante attriti di ogni genere, per un anno circa il controllo del territorio riesca a funzionare in modo accettabile grazie a una cogestione del potere tra occupanti e collaborazionisti e nonostante la diffidenza reciproca, che si incrina solo a livello locale rafforzando lo stereotipo della "brava gente".
Questo stereotipo della "brava gente" viene trattato in Una pagina strappata, quarto capitolo del volume in cui Gobetti mostra come lo si potesse considerare già consolidato durante l'occupazione, e come i comandi invocassero la sua disconferma con svariati appelli alla durezza e all'intransigenza che ebbero traduzione operativa nella circolare 3c emanata dal generale Roatta nel marzo 1942, con cui si volevano incentivare le operazioni offensive e la repressione, accogliendo esplicitamnte il principio di correità della popolazione per le aree interessate da attività partigiane e facnedo un metodo della politica del terrore contro i civili, con relative rappresaglie, deportazioni, confische, catture di ostaggi e fucilazioni. Ordini draconiani che nonostante qualche memorialista sostenga il contrario, venivano normalmente eseguiti con frequenti eccezioni solo per le rappresaglie, che dato il numero delle perdite subite dagli occupanti avrebbero comportato autentiche stragi. "In definitiva tra le Fosse Ardeatine, la strage di Kragujevac e i 180 montenegrini fucilati da Pirzio Biroli esiste solo una differenza numerica, non di ordine strategico o morale. Bisogna ricordare infatti che si sta parlando di esseri umani, spesso del tutto innocenti, uccisi senza processo", specifica l'A. Alle rappresaglie si affiancano tribunali che istruiscono decine di migliaia di processi che si concludono con condanne a morte in pochissimi casi, nonostante la parzialità dei giudici e le sentenze sbrigative. L'A. illustra quindi lo strumento più usato per imporre il controllo sui territori occupati, quello dell'internamento. Centomila jugoslavi vengono deportati a più riprese in varie località della penisola italiana in campi friulani, veneti, toscani e umbri, di varia gestione e capienza, finché il loro numero non costrinse la Seconda Armata ad approntarne uno sull'isola di Rab che arrivo a detenere diecimila prigionieri. Tutte le situazioni erano accomunate da condizioni di vita estremamente precarie di cui le autorità avevano documentata conoscenza e che portarono a un totale stimato in almeno quattromila vittime. Nei territori occupati la circolare 3c si traduce nella pratica della terra bruciata che rende inabitabili intere regioni interne e porta alla fame buona parte della popolazione residente nei territori occupati. I tratti distintivi dell'occupazione diventano i saccheggi -teoricamente sanzionati- e gli incendi delle abitazioni, mentre la denutrizione provoca epidemie; la fame diventa parte integrante della strategia del terrore voluta dagli occupanti; chi tra loro osa rilevarne la demenzialità rischia il posto.
Gobetti rileva le caratteristiche da guerra coloniale della strategia di occupazione: superiorità militare e tecnica, repressione brutale della guerriglia a spese della popolazione civile, ampio ricorso a truppe ausiliarie locali e accordo con le élites. Roatta arrivò al punto di proporre l'uso di gas tossici contro i partigiani.
La "brava gente" commise un certo numero di crimini comuni; l'eccesso di potere garantito dagli alti gradi e avallato dalla propaganda, il clima di impunità diffusa e il declassamento a "fuorilegge" di intere popolazioni consentirono prevaricazionio di ogni genere, pur in un modello da cui ben pochi eserciti della storia contemporanea hanno preso le distanze. A occupazione finita inoltre nessuna Norimberga fu organizzata per i 750 individui di cui la Jugoslavia chiedeva l'estradizione. Un silenzio-negazione che rafforzò lo stereotipo della brava gente. L'autodifesa degli inquisiti concordò sull'additare la brutalità dei partigiani nei confronti degli occupanti. Un'immagine sedimentatasi nell'immaginario, anche grazie all'attenzione politica e mediatica dedicata al fenomeno delle foibe. Ovviamente le fonti storiche non concordano, perché le denunce della memorialistica non trovano riscontro né in testimonianze dirette né nei documenti dell'epoca. Gli episodi di violenza gratuita verificati dalle fonti sono molto rari ed esiste una verificabile sproporzione numerica tra le migliaia di fucilati e di deportati e le poche decine di esecuzioni compiute dai partigiani, di cui sono in genere vittime graduati e membri di milizie politiche. Ai prigionieri i partigiani offrono l'opportunità di entrare nelle loro file o li adibiscono a lavori di fatica fino alla liberazione o allo scambio, spesso effettuato nonostante l'esplicito divieto degli alti comandi. La memorialistica raccolta da Gobetti mostra la difficoltà di collocare l'esperienza dell'antiguerriglia nel contesto postbellico, caratterizzato dall'esaltazione retorica della guerra partigiana. I testi disponibili mettono in risalto una quotidianità annoiata resa problematica dal poco cibo e dalla scarsa igiene in cui si evidenziano i rapporti ambigui con la popolazione locale ("il nemico è ovunque..."), interrotta da eventi brutali, drammatici e soprattutto improvvisi e da rastrellamenti contro un nemico sfuggente (e informatissimo di tutto) che spesso non portano a nulla e che ottengono in risposta imboscate micidiali anche per il morale degli occupanti.
Il quinto capitolo sui Valzer proibiti italo-četnici riprende il tema dell'organizzazione delle Mvac e del rovesciamento nella politica delle nazionalità che essa comportò, con l'identificazione dei serbi come alleati naturali in funzione anticroata e relativo cambio di toni da parte degli alti gradi, con palese disappunto di politici e diplomatici. Il governo di Pavelić viene incolpato dell'inasprirsi della resistenza partigiana e dell'invadenza tedesca, forte di una evidente superiorità economica e militare, in territori che la diplomazia prebellica aveva considerato e trattato come il cortile di casa. Di qui la "alleanza col nemico" che fa da titolo al volume. Un'alleanza che contraddice la linea diplomatica adottata fino a quel momento e anche gli schieramenti militari internazionali. Draža Mihailović è ministro della guerra del governo jugoslavo in esilio, ma i suoi uomini operano come truppe ausiliarie per lo stato che occupa la penisola italiana, lo stesso con cui il governo jugoslavo è formalmente in guerra. Nel maggio 1942 Mihailović stabilisce un proprio quartier generale in una località isolata del Crna Gora. Agisce indisturbato: agli occupanti, che cercano di contattarlo direttamente per rafforzare i rapporti con i serbi in contrapposizione all'alleanza tra tedeschi e croati e che sanno benissimo che presso il suo quartier generale sono presenti ufficiali britannici, basta che non apra un secondo fronte. Convinto della vittoria alleata, Mihailović non andò mai oltre rapporti che gli consentissero di lottare contro i partigiani comunisti e di ottenere armi senza compromettersi politicamente. Questo, mentre indicava esplicitamente ai subalterni di collaborare con gli occupanti in un quadro complessivo che doveva creare una vasta zona controllata da serbi (a spese dei croati), in attesa di uno sbarco alleato.
L'A. segnala come gli occupanti non avessero tra le priorità il contrasto alle violenze dei collaborazionisti contro i civili, la cui causa viene genericamente ascritta ad un'atavica propensione per il sangue, e come la pulizia etnica ante litteram dei serbi contro i musulmani e i croati sia stata in più di un caso agevolata dalla loro logistica o dalla loro connivenza. Da una fonte citata dall'A. si viene a sapere che la propaganda definiva lo stato che occupa la penisola italiana "l'unica grande potenza Europea sotto la quale vivono circa quattro milioni di mussulmani con parità di diritti e di doveri", ma la sua diplomazia e il suo apparato politico e militare non sembrarono intenzionati a mobilitare le popolazioni musulmane delle zone occupate, in cui vengono organizzate bande ausiliarie di limitatissima numerosità. Cliché orientaleggiante, esperienza coloniale e pregiudizio razzista furono determinanti. L'unica formazione musulmana della Mvac viene messa agli ordini dei četnici, va allo sbando nella battaglia della Neretva, il suo comandante viene ucciso probabilmente dai četnici stessi. L'iniziativa tedesca invece riesce a costituire due divisioni di Waffen SS con ventiseimilia uomini. Nonostante le leggi razziali in vigore, gli ebrei delle zone annesse e di quelle occupate non vennero perseguitati al di là della vigilanza. Violenze e distruzioni ad opera degli ustaša sono accolte con esecrazione. Dopo l'aumento delle pretese tedesche in questo senso molti ebrei vennero internati a Rab e poterono mettersi in salvo dopo l'8 settembre 1943. Le fonti disponibili non permettono secondo Gobetti di chiarire le ragioni di un trattamento tanto diverso rispetto a quello adottato verso le altre popolazioni civili sottoposte all'occupazione. Si può ipotizzare che nel 1943 la previsione della sconfitta imminente avesse consigliato di dare segni distensivi agli alleati, e che nei mesi precedenti questo atteggiamento fosse invece dettato da realismo politico come la conservazione di autonomia decisionale rispetto ai tedeschi o la costituzione di una "massa di manovra" utile in caso di eventuali plebisciti.
La pace lontana si apre con la constatazione che nella primavera del 1943 i Balcani non sono più l'appendice periferica di un impero in espansione ma la retrovia del fronte orientale, e il probabile punto di sbarco degli alleati occidentali. Gli occupanti lascerebbero lo stato indipendente croato a se stesso per asserragliarsi in Dalmacija lasciando alla Mvac il compito di creare una fascia di sicurezza, ma i tedeschi organizzano una iniziativa antipartigiana di enorme respiro e pretenderebbero anche l'eliminazione dei četnici come forza combattente in considerazione dei pesantissimi e documentati dubbi sulla loro fedeltà. Al giugno 1943 nonostante le enormi perdite i partigiani comunisti sono sfuggiti agli accerchiamenti, hanno sbaragliato essi stessi i četnici nella battaglia della Neretva e sono rimasti unici interlocutori degli Alleati. Nelle operazioni del 1943 lo stato che occupa la penisola italiana fa il comprimario, si affida alla Mvac serba che i tedeschi vorrebbero cancellare e perde migliaia di uomini e grandi riserve di armamenti anche pesanti nella distruzione sistematica dei presidi isolati da parte dei partigiani di Tito intanto che i četnici di Mihailović tracollano minati dalle sconfitte sul campo, dalle direttive contraddittorie e dal radicale intervento tedesco che disarma e arresta le formazioni rimaste.
Gobetti traccia le vicende essenziali dei servizi segreti britannici in Jugoslavia, con l'iniziale ricerca di contatti con la percepita resistenza anticomunista di Mihailović e l'incrinarsi dei rapporti nel 1943 a fronte dei rovesci subiti e delle manchevolezze dimostrate, fino all'invio dell'agente Deakin al quartier generale di un Tito percepito come autonomo da Stalin, efficace militarmente e forte di un vasto consenso.
Dalla fine del 1942 i collaborazionisti, armati e sfamati dagli occupanti e più numerosi dei partigiani, si trovano a essere dalla parte destinata alla sconfitta. Insidiosi per la conoscenza della lingua, del territorio e della realtà sociale subiscono però continue sconfitte negli scontri aperti. L'esercito partigiano invece funziona senza appoggi esterni, ottiene sussistenza dalle popolazioni solidali e, convinto che la guerra si vinca innanzitutto nella mente delle popolazioni per le quali si pretende di combattere, dedica a una propaganda multiforme ed efficace le risorse che gli avversari devono dedicare a pietire armi e benevolenza. I partigiani di Tito secondo Gobetti mostrano una netta superiorità già nei primi due anni di guerra presentando la loro guerra come al tempo stesso di liberazione della patria dagli invasori e come rivoluzione sociale contro le vecchie élites colpevoli della corruzione della vecchia Jugoslavia monarchica, della disfatta del 1941 e adesso dell'odio etnico e delle stragi. Mentre gli anticomunisti si rifanno a teorie politiche ottocentesche e ai simboli di un passato medievale come la battaglia di Kosovo polje o il mitico regno di Tomislav, i comunisti guardano al futuro e offrono esempi di impegno ideale, sacrificio e forza di volontà. A consolidare il consenso verso i partigiani specie in settori della popolazione da sempre esclusi dal potere -e di cui gli anticomunisti non si curano- sono la loro correttezza verso i civili, la disciplina, l'attenzione a non abbandonare o lasciare al nemico i feriti. I tre quarti dei combattenti sono di età tra i sedici e i ventun anni, a condurre il partito sono studenti, docenti e funzionari di stato spesso poliglotti che gli invasori provenienti dalla penisola italiana derubricano a "massa intellettualoide giovane senza esperienza, esaltata dalle chiacchiere e dal comunismo". Gobetti paragona la realtà jugoslava a quella cinese dello stesso periodo, in cui la guerra di liberazione è combattuta da contadini mobilitati da un piccolo nucleo di intellettuali tramite la mediazione di un ceto istruito di origine rurale, in lotta per un progetto alternativo al modello jugoslavo autoritario, capitalista e serbocentrico che si era dimostrato fallimentare già negli anni precedenti al conflitto. L'adozione dell'ideologia jugoslavista consente al movimento partigiano di saldare il conflitto ideologico a quello nazionale: l'invasore è un avversario politico e al tempo stesso un nemico nazionale. Il movimento di liberazione rappresenta una forza autenticamente multinazionale e una alternativa alle stragi reciproche, cosa che allarga il suo consenso a tutti i gruppi nazionali anche minoritari. Le formazioni anticomuniste e nazionaliste vedono mortificati i loro sogni di grandezza a causa delle rinunce territorali imposte dagli occupanti: i partigiani sono liberi di reclamare Kotor, Dalmacija, Istra, Trst e anche Klagenfurt e Thessaloniki. Ogni popolo jugoslavo nella propaganda comunista sembra poter ottenere qualcosa: un territorio, un'autonomia, un riconoscimento.
A metà del 1943 lo stato che occupa la penisola italiana cominciò a trovarsi esso stesso sotto minaccia, e iniziò il disimpegno dai territori jugoslavi avvicendando anche tutte le alte cariche pur senza rinunciare alla collaborazione con le residue formazioni serbe. I rastrellamenti sempre meno efficaci e l'attesa di uno sbarco alleato dato per imminente accompagnano gli occupanti verso l'armistizio dell'8 settembre, in previsione del quale furono diramate parziali e tardive disposizioni lasciando le singole unità alle prese col proprio destino. Prigionia per mano tedesca e unione con i partigiani gli esiti più comuni; le strutture politico-militari create durante l'occupazione sopravvivono all'uscita di scena dello stato che occupa la penisola italiana e combattono a fianco dei tedeschi fino alla fine delle ostilità. I leader collaborazionisti, durante o dopo il conflitto, finirono tutti incarcerati o giustiziati con poche eccezioni.
Al momento della colliquazione delle forze occupanti provenienti dallo stato che occupa la penisola italiana i grandi sconfitti sono i četnici, vittime di una ambiguità che è allo stesso tempo loro forza e loro condanna dopo la perdita dell'unico alleato rimasto, che comporta anche la fine di ogni alternativa praticabile alla Jugoslavia socialista.
Eric Gobetti - Alleati del nemico. L'occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943). Laterza 2013, 208 pp.
