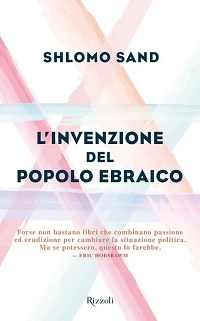
Il lungo saggio di Schlomo Sand attacca uno dei miti fondanti dello stato sionista e delle sue pretese sulla Palestina, l'idea che esista un "popolo ebraico" omogeneo costretto all'esilio dai romani nel I secolo e finalmente tornato dopo due millenni nella propria antica terra. Nell'introduzione all'edizione inglese Sand spiega che lo scritto è stato scritto e pubblicato in ebraico nello stato sionista dove sarebbe stato accolto con considerevole favore. Sand è convinto che uno stato che intenda considerarsi "del popolo ebraico" e non un corpo che rappresenta tutti i cittadini inclusi entro i suoi confini non possa essere definito uno stato democratico: se essere ebreo per via matrilineare consente a chiunque di poter vivere ovunque pur essendo sicuro che lo stato sionista gli appartenga, "chiunque non discenda da lombi ebraici e viva a Giaffa o a Nazareth sa che non possiederà mai lo stato in cui è nato". Fuori dai periodi di conflitto lo stato sionista sarebbe caratterizzato da un pluralismo liberale cui potrebbe partecipare a pieno titolo -vita politica compresa- chiunque non metta in discussione la natura ebraica dello stato, e i miti nazionali vi starebbero allentando la presa lasciando il posto a un "postsionismo" che non li considera intoccabili. L'ambiente accademico ne sarebbe ancora intriso, da cui le critiche ricevute da un A. che sottolinea di aver consultato quasi esclusivamente fonti già note agli storiografi sionisti.
Nell'introduzione Sand riporta le vicende biografiche di familiari, amici (come Mahmud Darwish) e allievi; tutte storie caratterizzate da un rapporto non univoco e non lineare né con l'identità ebraica né con la sua definizione giuridica e operazionale in uso nello stato sionista. Dopo aver esposto i miti fondanti che gli storici del XIX secolo produssero e fornirono agli stati nazionali e ai loro sistemi di istruzione, Sand nota con sarcasmo che nello stato sionista non c'è stato bisogno di ricorrere a mitologie inverosimili; i suoi cittadini, specie se di origine ebraica, sanno che la loro storia "è basata su verità salde e precise" esposte con sarcasmo anch'esse, dalla consegna della Torah a Mosè sul Sinai alla diaspora, fino al ritorno in massa in una "terra disabitata e vergine che non aspettava altro che arrivassero gli ebrei per farla rifiorire". Nonostante l'attività accademica e i significativi sovvertimenti dei paradigmi che orientavano lo studio delle nazioni e dei nazionalismi, secondo Sand questa visione del passato ebraico si sarebbe cristallizzata su una concezione etnica e nazionale giunta senza scosse fino al XXI secolo. Anche davanti alle smentite più evidenti, ogni scostamento dalla narrativa dominante sarebbe stato inficiato dalle esigenze del nazionalismo, che negli ambienti accademici dello stato sionista conterebbero anche su una separazione fra i dipartimenti di Storia degli ebrei -dominati dalla retorica apologetica anche a fronte di smentite e disconferme evidenti- e quelli di Storia generale e del Medio Oriente. Nello stato sionista le scarse opere che hanno cercato di rimettere in discussione i paradigmi di base della storia nazionale non avrebbero avuto alcuna eco, e spesso non sarebbero stati neppure tradotti quando pubblicati in altre lingue. Sand afferma di aver scelto nella redazione del saggio di correre rischi di soliti non concessi a uno specialista, occupandosi di varie discipline stante l'insuccesso nella ricerca di qualcuno che collaborasse al misfatto: "studiosi della Bibbia, storici del periodo antico, archeologi, medievalisti e soprattutto specialisti di storia degli ebrei" avrebbero avuto ogni diritto di risentirsi "davanti all’intruso che ha sconfinato illegalmente nei loro campi di ricerca". Elencando i principali temi affrontati dallo scritto, Sand nota tra l'altro che nella storia recente in Europa sostenere che gli ebrei appartenessero a un popolo straniero è valso accuse di antisemitismo, mentre oggi le stesse accuse verrebbero mosse a chi sostiene che gli ebrei non abbiano mai costituito un popolo o una nazione. Un quarto dei cittadini di uno stato che si definisce "stato ebraico" non sono ebrei e non possono quindi sentire quello stato come il proprio; lo stesso stato ebraico fin dalle origini avrebbe rifiutato l'assimilazione degli abitanti autoctoni, escludendoli deliberatamente e rifiutando di diventare una democrazia consociativa di modello svizzero o belga, o multiculturale su modello britannico. Il mito di una nazione eterna destinata a riunirsi un giorno nel "paese natio" continuerebbe invece ad alimentare una compagine che viola un principio fondamentale della democrazia moderna e preserva una etnocrazia priva di confini, in un mondo in cui gli ebrei sono cittadini con pieni diritti e non esuli perseguitati.
Sand apre il primo capitolo (Creazione di popoli: sovranità popolare e aspirazione all’uguaglianza) trattando dei vocaboli nazione, popolo, razza ed éthnos e delle loro trasformazioni semantiche, specificando che nel libro l'utilizzo del termine "popolo" sarebbe servito a indicare "un gruppo di persone piuttosto fluido, di solito premoderno, e presente soprattutto nelle prime fasi della modernizzazione" che avrebbe costituito una comunità vivente in un contesto territoriale ben determinato, unita al massimo da regole e pratiche culturali laiche comuni poco consolidate secondo linee di confine ancora di là da venire prima della comparsa degli stati-nazione. Il consolidamento di questi ultimi avrebbe fatto la fortuna dei "popoli" usati come rampa di lancio per il proprio decollo, e la rovina di quelli esclusi dai processi egemonici, le cui élite intellettuali avrebbero a volte reagito inasprendo e amplificando la portata delle differenze per farne presupposti di una lotta per l'autodeterminazione. A differenza dei "popoli", destinati a comparse, scomparse e ricomparse nel corso della storia, secondo Sand le "comunità religiose" o le "civiltà religiose", anch'esse suscettibili di prestarsi come materia prima per il consolidamento di stati nazionali, avrebbero avuto lunghe durate grazie all'esistenza di un ceto intellettuale fedele alla tradizione. Dopo aver esaminato la nazione come frutto dell'impatto con la modernità, Sand ne adotta una dettagliata e articolata definizione basandosi sugli scritti di Benedict Anderson, Ernest Gellner e di Eric Hobsbawm. Sand indica con nazione un gruppo umano in cui il sistema educativo crea una cultura omogenea che pretende di essere condivisa e accessibile e in cui si forma una concezione di uguaglianza civile tra appartenenti, tenuti insieme a loro volta da una continuità linguistico-culturale condivisa; questo corpo civico si percepisce come sovrano. Ogni nazione avrebbe un territorio comune di cui i membri si sentono -e stabiliscono- di essere insieme gli esclusivi proprietari, caratterizzandolo anche -in epoche pre-globalizzazione- con forti relazioni tra attività economiche. Caratteristico della modernità proprio come la divisione del lavoro, la mobilità sociale e le tecnologie per la comunicazione, sarebbe il senso identitario esteso alla massa produttiva e non più retaggio di sole élite o gruppi ristretti. Sand indica nel nazionalismo la consapevolezza ideologica unificante alimentata con attività culturali collettive e con la creazione di una memoria condivisa, indispensabile al mantenimento della coesione e della fedeltà a un gruppo altrimenti astratto. Storicamente, il nazionalismo avrebbe anche colmato i vuoti lasciati dall'allentamento dei legami tipico della modernità. Sand indica gli esordi dell'ideologia nazionale nella rivoluzione puritana inglese del XVII secolo e la sua maturazione nelle rivoluzioni di fine XVIII secolo e nei loro messaggi nazionaldemocratici. La nazione sarebbe diventata l'unico ambito possibile per la realizzazione della sovranità popolare; con l' introduzione dell'istruzione obbligatoria e del suffragio universale l'ideale nazionalista avrebbe raggiunto la piena maturità alla fine del XIX secolo; pochi anni dopo Carlton Hayes, davanti alla prova dei fatti, ne avrebbe descritto gli aspetti distruttivi sottolineando anche i legami del nazionalismo con i tratti distintivi della civiltà cristiana. L'A. nota che ideologie e movimenti politici emersi successivamente si sarebbero affermati solo nella misura in cui avrebbero saputo scendere a patti con il nazionalismo, facendosi a volte portatori di versioni radicali e aggressive di quest'ultimo. Sand esamina quindi il lavoro di Hans Kohn, il suo tentativo di identificare le diverse espressioni del nazionalismo e le principali critiche mossegli, considerandone corretta la considerazione sul progressivo (sia pur non lineare) affievolirsi dei miti etnocentrici nei nazionalismi occidentali, in cui si sarebbe fatto strada un immaginario civico in cui il futuro è più importante del passato. Alla distinzione tra nazionalismi civici e nazionalismi etnici, Liah Greenfeld avrebbe affiancato il criterio del collettivismo; l'A. conclude però rilevando come a tutt'oggi mancherebbe una sintesi condivisa in grado di dare ragione di tutta la gamma delle espressioni nazionali e del loro sviluppo. In tutti i casi gli intellettuali sarebbero stati i principali attori della formazione delle entità nazionali e forse anche i loro principali produttori di capitale simbolico. Rifacendosi anche a Gramsci, Sand nota che nelle società premoderne gli intellettuali avrebbero fornito una coscienza egemonica in grado di puntellare la gerarchia sociale eliminando la necessità di mantenerla con la forza, al punto che credenze, riti e immagini da essi diffusi sarebbero sopravvissuti ai sistemi politici perché percepiti come al servizio di tutti. L'affermarsi dell'economia di mercato avrebbe portato alla riformulazione dei legami tra gli intellettuali e la borghesia in ascesa, e alla loro trasformazione in professionisti e in funzionari pubblici. I controllori degli apparati del nuovo stato-nazione avrebbero elaborato un discorso universale che pretendeva di essere a servizio di tutti i membri della nazione.
Col secondo capitolo dedicato alla Mitostoria la trattazione entra nello specifico. Sand intende iniziare confutando l'assunto per cui in principio Dio avrebbe "creato la nazione". Dopo Giuseppe Flavio e la sua storiografia fedelmente biblica, l'atteggiamento escatologico dell'ebraismo rabbinico avrebbe fatto evitare interessi storiografici fino alla fine del XVII secolo, al punto che l'ugonotto Jacques Basnage avrebbe potuto presentare la propria Histoire et religion des Juifs come continuazione di quella di Giuseppe Flavio e raffigurarvi gli ebrei come vittime privilegiate della corrotta istituzione del papato. L'A. considera poi il clima socioculturale del nazionalismo nascente in cui dal 1820 avrebbero operato storici propriamente ebrei come Isaak Markus Jost, interessati in primo luogo alla emancipazione e alla laicizzazione dello stato. Lo studio del passato ebraico e dei suoi aspetti positivi sarebbe stato percepito per alcuni decenni come utile all'integrazione della comunità ebraica nella società tedesca; Jost avrebbe modificato le proprie convinzioni solo con il consolidarsi del nazionalismo tedesco e col suo puntare alla costruzione di una comunità escludente, aprendo alla concezione della Bibbia come testimonianza storica affidabile per la definizione di una identità ebraica moderna in termini nazionalisti. A trent'anni dall'inizio della pubblicazione delle opere di Jost, Heinrich Graetz avrebbe iniziato a pubblicare una fortunata Geschichte der Juden ispirata a questo principio e -col trionfo del nazionalismo tedesco sotto Bismarck- a quello dell'esistenza di un Volksstamm ebraico eterno. Nella costruzione di un mito fondante Graetz avrebbe scollegato il testo biblico dagli apparati a commento tradizionalmente usati come mediatori da chi considerava il testo ispirato divinamente e quindi al di là di ogni possibilità di comprensione spirituale. Gli aderenti all'illuminismo ebraico, dalla fede metafisica vacillante, avrebbero consolidato l'identità propria e quella di gruppo costruendo un proprio nazionalismo rifacendosi all'antica sovranità statale prospettata dal testo biblico. Graetz avrebbe sorvolato sui primi eventi miracolosi (poco costruttivi negli anni di Charles Darwin) per poi considerare la rimanente narrazione biblica come verità indiscutibile da difendere con veemenza contro qualsiasi detrattore, e puntare sul regno di David e sui suoi successi militari indicandolo come la antica forgia di un popolo dalle caratteristiche eccezionali e moralmente vigorose. Sand nota che Graetz sarebbe approdato all'idea di un ebraismo esclusivo, dotato di confini rigidi. Sand nota anche che nella seconda metà del XIX secolo i più eminenti intellettuali avrebbero iniziato "a sguazzare allegramente nell’enorme pantano dei preconcetti sulla razza e degli stereotipi orientalisti"; in breve la scienza della razza sarebbe stata data per scontata e avrebbe avuto almeno fino al 1890 pochi detrattori. In questo clima Moses Hess avrebbe proposto in Roma e Gerusalemme una lettura della storia come lotta di razza e di classe, sostenendo le origini razziali dei contrasti fra ebrei e non ebrei; "razza originaria", gli ebrei avrebbero mantenuto la propria "inalienabile" integrità attraverso i secoli, anche grazie a una religione sviluppatasi come "culto storico nazionale". I rapporti fra Hess e Graetz avrebbero portato quest'ultimo a concludere la propria lunga opera, dopo il 1870, con toni favorevoli all'eccezionalismo: "popolo messianico", gli ebrei avrebbero portato l'umanità alla salvezza. Sand riferisce che Heinrich von Treitschke avrebbe pesantemente dissentito con Graetz, statuendo l'assimilazione come impossibile a causa della natura contrapposta e inconciliabile della identità ebraica e di quella tedesca e caldeggiando la creazione di uno stato ebraico "da qualche parte" fuori dalla Germania. Il tutto in un momento di crisi economica in cui era diffuso un antisemitismo politico di origine popolare diretto soprattutto contro una recente ondata di emigrati aschenaziti. Theodor Mommsen avrebbe preso le distanze da von Treitschke in nome di un nazionalismo civico privo di isolazionismo, in cui gli ebrei sarebbero stati considerati attori importanti nella costruzione della nuova identità tedesca. Graetz, con la sua costruzione di un passato nazionale collettivo da storico protonazionale non sionista, avrebbe avuto molta fortuna nella ostjudentum tardo ottocentesca grazie alle traduzioni in russo di Simon Dubnow. Sand indica in Dubnow un autonomista sostenitore di uno spazio autonomo per lo "straordinario" popolo ebraico nel luogo in cui esso già risiedeva e dove sussisteva una cultura popolare yiddish viva e produttiva. Dubnow avrebbe rinforzato il proprio autonomismo con l'idea di una tradizione spirituale di lungo periodo tramandatasi con le generazioni. Per la prima volta con Dubnow la fede religiosa sarebbe diventata strumento imprescindibile per la definizione dell'identità nazionale; allo storiografia scientifica sarebbe spettato il compito di costruire una memoria e una identità ufficiali e oggettive. Nella Weltgeschichte des jüdischen Volkes iniziata nei primi anni del secolo scorso Dubnow si sarebbe avvalso dei progressi dell'archeologia per proporre la storia di un "corpo nazionale vivo" all'epoca composto da tutte le comunità ebraiche autonome, che avrebbero costituito una entità nazionale unica in considerazione della comune origine storica del "popolo eterno". Dubnow avrebbe estrapolato gli elementi biblici più o meno coerenti con la realtà e affrontato i raconti antichi come metafore, mettendo a punto la strategia narrativa poi adottata da tutti gli storici sionisti e curando di far risalire la data di nascita del "popolo" il più lontano possibile nel tempo. Secondo Sand, Dubrow avrebbe iniziato "una lunga tradizione nel nazionalismo ebraico che in seguito avrebbe cercato di convalidare le storie della Bibbia (e naturalmente il diritto al possesso della 'terra d’Israele' da parte del 'popolo d’Israele')" con gli strumenti dell'archeologia e grazie alla tendenza degli archeologi cristiani a non contraddire il Vecchio Testamento. Davanti a eventuali (ed evidenti) contraddizioni fra dato archeologico e testo biblico, Dubrow avrebbe preferito la "verità" del testo arrivando a una narrazione storica fedele a quella biblica, pur epurata dalle descrizioni sovrannaturali e dagli interventi diretti della divinità. Secondo l'A., avrebbe recepito le preoccupazioni völkisch dei Treitschke e dei Graetz adottando la stessa rigida concezione identitaria etnocentrica dei nazionalismi contemporanei, rinforzata dalla antichità documentale cui poteva rifarsi. Sand esamina a questo punto A Social and Religious History of the Jews pubblicata negli USA da Salo Wittmayer Baron nel 1937 e poi nel 1952, in cui si trova una descrizione della vita delle comunità ebraiche nel mondo in cui le "impalcature protonazionali" costruite sulla Bibbia da Graetz e Dubnow sarebbero diventate comunque "strutture portanti ineludibili" e munite di avallo accademico. In Baron la storia biblica, pur laica, apparirebbe subordinata a un discorso protosionista, e venato di un eccezionalismo costruito sull'origine etnica e sull'amore per il passato, sul persistere "miracoloso e misterioso" degli ebrei come popolo in tutto il corso della storia. Baron avrebbe cercato di ritrarre il "popolo" ebraico come in equilibrio fra l'etnocentrismo e l'universalismo umanista, presentandolo come capace di convivere con altri gruppi senza troppo confondervisi. In questo, non avrebbe presentato nella sua opera alcuna aspirazione a una sovranità politica e men che meno a un ritorno in una "antica patria". L'aver letto la storia biblica attraverso la lente dell'esilio sarebbe costato a Baron le critiche di Yitzchaq Baer, docente di storia degli ebrei all'università ebraica di Gerusalemme. Baer avrebbe rilevato in Baron una separazione tra monoteismo ebraico e terra d'Israele, e la mancanza di rilievo per una aspirazione a una sovranità indipendente che avrebbe invece caratterizzato gli ebrei attraverso la storia. In Baer la "rinascita ebraica" sarebbe stata il ritorno alla "consapevolezza nazionale dell'antichità" senza il cui "archetipo sacro" una "idea nazionale europea" non sarebbe stata nemmeno immaginabile. Sand sottolinea come nelle università dello stato sionista, secondo una suddivisione fortemente voluta da Ben Zion Dinur, esistano un dipartimento di Storia e uno di "Storia del popolo ebraico e sociologia degli ebrei"; le due discipline vi sarebbero organizzate secondo principi, strumenti, concetti e cronologie differenti. Dinur è ricordato da Sand anche come autore di opere considerate di riferimento per oggettività e sistematicità. Dinur avrebbe proceduto nelle proprie Toledot Yisrael dividendo la Bibbia in sezioni, e strutturando tutta la sua opera come un sistema di citazioni bibliche epurate dai riferimenti trascendenti alternate con altre fonti, dando alle prime la precedenza in caso di contrasti. Dinur avrebbe considerato la scrittura storica come una autobiografia nazionale, ovvero una storia militante, in cui evidenziare il consolidamento e lo sviluppo del "popolo di Israele" dalle origini all'epoca presente. L'A. ricorda come il maggior contributo della storiografia biblica alla creazione di una coscienza nazionale si trovasse nel fatto che su di essa si basava il diritto alla "terra di Israele"; Dinur avrebbe cercato di dimostrare la centralità della "terra di Israele" e dell'aspirazione a farvi ritorno in tutta la lunga esistenza del popolo ebraico; i fondatori della storiografia sionista avrebbero completato il processo di nazionalizzazione della Bibbia e la sua trasformazione in un libro di storia attendibile iniziata da Graetz e proseguita da Dubnow e Baron. Dinur si sarebbe personalmente adoperato, all'interno di un circolo di intellettuali e politici di spicco, per fornire materiali d'appoggio a David Ben Gurion, che avrebbe fatto ampio ricorso alle storie bibliche per la propria comunicazione politica. Nella formazione e nella diffusione dell'ideologia sionista la "mitostoria" biblica, che avrebbe oscillato fra pragmatismo politico manipolatorio e sincera fede nelle verità ancestrali, avrebbe avuto un ruolo fondamentale. L'A. nota come la Bibbia sarebbe diventata fondamentale per l'elaborazione di una sovranità statale rinnovata, permeando di sé finanche i nome di persone e località. Nell'interpretazione "corretta" della storia ebraica e del suo valore per una manipolazione ideologica del presente, insegnanti, scrittori e saggisti vi avrebbero addirittura preceduto gli ambienti accademici. La Bibbia sarebbe stata introdotta come materia di studio a sé nelle prime scuole fondate negli insediamenti in Palestina, dove avrebbe costituito un punto di partenza "etnico" per l'esistenza della comunità religiosa dispersa nel mondo e per "creare l'autoconvinzione al diritto di possesso della terra" evidenziando gli aspetti eroici e militari del testo. Con la fondazione dello stato sionista questo tipo di studio biblico autonomo, unito a lezioni di storia ed escursioni sul campo sarebbe stato la norma in tutte le branche del sistema scolastico; Moshe Dayan avrebbe lasciato una testimonianza autobiografica in cui le vicende eroiche dell'antichità e le sue vicende personali nelle guerre del 1948, del 1956 e del 1967 avrebbero combaciato come se si svolgessero "su un palcoscenico eterno in cui la dimensione storica non esiste più". Yigal Yadin avrebbe invece raccolto l'eredità di archeologi cristiani già all'opera alla fine del XIX secolo nella difesa della veridicità delle scritture bibliche, divulgando solo scoperte che collimassero con esse. Le incongruenze che contraddicessero irriguardosamente le scritture sarebbero state risolte, da lui e dai successori, con argomentazioni tese comunque ad armonizzare i reperti al "coro fidato della Bibbia" e disinteressandosi dei lunghi periodi "non ebraici" della storia. Dopo il 1967 gli archeologi sionisti avrebbero potuto effettuare scavi nel cuore della Giudea biblica e a Gerusalemme, convintissimi che la veridicità dl testo sacro avrebbe ricevuto conferme tali da saldare una volta per tutte "l'antico popolo con la madrepatria storica". Sand nota invece che a fronte dei ritrovamenti che ne mettevano in discussione la natura evenemenziale e politica, l'archeologia dell'epoca biblica avrebbe iniziato "a manifestare timidi segnali di disagio". Dopo il 1960 i dati archeologici avrebbero iniziato a mettere pesantemente in discussione cronologia e fondamento storico della Bibbia, e studiosi non sionisti avrebbero potuto sostenere che i suoi racconti evenemenziali non erano confusi miti popolari trasmessi e "perfezionati" col tempo, ma redazioni ideologiche consapevoli comparse centinaia di anni dopo i fatti narrati, i cui redattori avrebbero mirato a costruire e saldare legami con culture alte assai più che a presentarsi come radicati nella propria terra. Sand nota divertito come vari miti, dalla fuga dall'Egitto alla conquista di Canaan (nel libro di Giosuè descritta in modo piuttosto controproducente per chi tiene molto a presentarsi come vittima di un genocidio) sarebbero stati confutati dall'archeologia. I difensori dell'antico testo "nazionale" avrebbero imparato a sminuire la portata di dettagli tanto irriverenti attraverso "vaghe e confuse spiegazioni". L'archeologia antropologico-sociale avrebbe invece umiliato l'immaginario passato glorioso: il decimo secolo prima di Cristo di David e Salomone e del loro regno di Giuda presuntamente esteso dall'Eufrate all'Egitto non avrebbe presentato né costruzioni monumentali né una particolare ricchezza nella cultura materiale. A nord, il regno di Israele sarebbe sempre risultato distinto, rivale, più potente e soprattutto politeista. Il nome del regno sarebbe stato fatto proprio dai tardi redattori del Pentateuco per ragioni di prestigio, e altri autori tardi avrebbero inventato la storia di un regno unificato senza riscontri reali.
Affrontando il tema del secolare dibattito sulla datazione e sugli autori degli scritti biblici, Sand condivide alcune conclusioni degli studiosi sionisti contemporanei per cui la Bibbia non avrebbe potuto essere scritta prima del tardo ottavo secolo prima di Cristo e che molte delle storie in essa contenuta non avrebbero alcuna base fattuale. Non ne condivide molte altre, specie quelle sull'uso del Pentateuco come elemento di coesione politica, di legittimazione della monarchia presso i ceti popolari e di veicolo di un monoteismo unificante. L'A. ritiene logico supporre che i materiali prodotti da scribi e segretari di corte in Giuda e in Israele siano state impiegati "con straordinaria libertà creativa" e con l'integrazione di miti e leggende ampiamente diffusi come fonti per la composizione delle narrazioni più importanti per la nascita del monoteismo. Il processo sarebbe avvenuto grazie alle rare circostanze in cui una élite palatina non tenuta a vincoli di fedeltà avrebbe goduto di una libertà di scrittura rivolta al contesto religioso anziché al potere monarchico. Il monoteismo, ritiene Sand, sarebbe nato non per motivi politici ma culturali, con l'incontro tra élite intellettuale e religioni persiane trascendenti, e sarebbe maturato successivamente dopo l'incontro col politeismo ellenistico. La storiografia protonazionalista sarebbe stata la prima a leggere i testi biblici come testimoni attendibili di processi ed eventi elevandoli a "mitostoria" incontestabile. Sand sottolinea come la Bibbia sarebbe stata usata come simbolo etnico, fornendo poderose pezze d'appoggio a genti eterogenee trovatesi smarrite "nel labirinto di una modernità veloce e turbolenta".
Il terzo capitolo espone le vicende che Sand considera inerenti l'invenzione dell'esilio, quando "molti pagani [...] si fecero giudei". Il mito dello sradicamento e dell'esilio di un intero popolo si sarebbe sviluppato nella tradizione cristiana prima di entrare in quella ebraica, per poi cristallizzarsi in una verità indiscutibile della storia generale. Con buona pace del sistema scolastico sionista e del solo Giuseppe Flavio, l'A. scrive che non esisterebbero prove archeologiche né testimonianze letterarie di una massiccia cacciata degli ebrei dopo la repressione della rivolta degli zeloti nel 70 d.C. e che solo alcuni centri urbani -Gerusalemme su tutti- avrebbero subito danni ingenti, la cui valutazione sarebbe stata ridimensionata dai dati archeologici. Anche i resoconti della successiva rivolta di Bar Kokba del 132, per quanto crudi, non menzionerebbero nulla di simile. Il mito dell'esilio si sarebbe sviluppato attingendo alla letteratura antiebraica cristiana; dopo l'affermarsi del cristianesimo il nesso tra cacciata e peccato, tra distruzione ed esilio sarebbe diventato presto parte fondamentale delle spiegazioni sulla presenza degli ebrei nel mondo, fino a contribuire alla definizione della loro identità. Simbolo di temporanea sconfitta, l'esilio sarebbe servito anche alla redenzione dei peccati; la sua conclusione escatologica sarebbe coincisa con la resurrezione dei morti e il ritorno collettivo a Gerusalemme, e in questo avrebbe acquisito una dimensione esistenziale sempre meno legata a un luogo fisico. Sand sottolinea che contrariamente a quanto sostenuto dall'ideologia sionista non sempre gli ebrei "aspirarono in ogni successiva generazione a tornare e stabilirsi nella loro antica patria". Migrare collettivamente per vivere una vita pienamente ebraica a Gerusalemme non avrebbe fatto parte dell'immaginario religioso, e coloro che avanzavano propositi analoghi sarebbero stati considerati delle eccentriche eccezioni. L'A. nota l'eccezione rappresentata dai caraiti, movimento legato al testo biblico che avrebbe respinto l'ebraismo rabbinico e le sue proibizioni, che fra il IX e X secolo avrebbe forse costituito la maggioranza degli abitanti di Gerusalemme. Nei secoli successivi e fino all'età contemporanea il rispetto delle prescrizioni del Talmud avrebbe dissuaso la gran parte della diaspora da iniziative del genere. "Gli ebrei non furono esiliati dalla loro patria con la forza, né vi ritornarono spontaneamente". Sand sottolinea come, al netto di resconti granguignoleschi, né Graetz né Dubnow né Baron parlino mai di espulsione dell'intero popolo, né per la rivolta degli zeloti ne per quella di Bar Kokba. Sand cita estesamente Yitzchaq Baer e le sue conclusioni su come la "nazione" ebraica avrebbe perso la sovranità, ma non sarebbe stata sradicata affatto; la vita sarebbe proseguita proprio come le rivolte periodiche almeno fino all'epoca della conquista araba, quando sarebbe iniziato un "esilio senza cacciata". Una periodizzazione ostica per il pubblico, che Ben Zion Dinur avrebbe adottato perché corrispondente alla storiografia scientifica e anche all'esigenza di ridurre al minimo "l'epoca dell'esilio", per ampliare invece quella del possesso nazionale del paese. Dinur avrebbe dovuto riportare conclusioni poco utili alla causa sionista, tra cui quella di un esilio volontario (e non imposto) a fronte del cambiare della maggioranza nazionale dopo l'arrivo degli arabi e una accelerazione negli espropri delle proprietà terriere. Dinur risolse la questione concludendo che seppure la cacciata dopo la distruzione del secondo tempio era un mito poco dettagliato, si poteva considerarla logica e giustificata alla luce delle espulsioni e delle peregrinazioni dei secoli successivi; Dinur avrebbe fatto degli ebrei un "corpo etnonazionale straniero in perenne movimento", conferendo alla diaspora una continuità che avrebbe potuto giustificare il ritorno. Divenuto ministro dell'istruzione nel 1951, il pur laico Dinur si sarebbe rifatto alla halakà per dichiarare decaduto il divieto rabbinico al ritorno. L'A. accenna a storici sionisti che pur meticolosi nella ricostruzione dell'esilio evitano di approfondire le circostanze storiche che avrebbero portato alla formazione di un popolo indomabile e capace di resistere a qualsiasi avversità; come se l'esilio fosse "un fondamento condiviso che non può mai essere messo in discussione", e che come tale appare effettivamente nel discorso popolare e nelle dichiarazioni politiche. A contrastare col mito dell'esilio forzato ci sarebbero state anche le evidenze a favore di comunità ebraiche fuori dalla Giudea ben prima del 70 d.C. -col Talmud babilonese ad attestare il radicamento in realtà culturalmente importanti- e la loro diffusione prima in tutto il Mediterraneo orientale in seguito allo sfaldamento dei confini persiani nel periodo ellenistico, e poi in tutto il mondo partico e romano. Le teorie sull'espulsione, insoddisfacenti, sarebbero state abbandonate da Graetz e dagli storici sionisti a favore di una visione in cui fatta eccezione per la massa di prigionieri ridotti a schiavi, gli ebrei avrebbero nel corso di alcuni decenni abbandonato una terra diventata pericoloso teatro di continue guerre. Nel sistema educativo dello stato sionista sarebbe stato adottato un climax in cui all'espulsione indicata come causa prima sarebbero seguite l'emigrazione per le difficili condizioni di vita, la migrazione volontaria e solo in ultimo il proselitismo. Sand è convinto che le teorie sulla espulsione e sulla emigrazione non reggano davanti alla prova dei numeri. In due secoli, le decine di migliaia di potenziali esuli in possesso delle competenze e dell'iniziativa necessarie avrebbero dovuto moltiplicarsi fino a raggiungere i quattro milioni di ebrei diasporici valutati dalle stime. Per una spiegazione credibile occorrerebbe quindi riferirsi al proselitismo per niente amato dalla storiografia sionista e meno ancora dalla sua divulgazione scolastica, nonostante vari testi biblici -soprattutto tra quelli che si ritengono composti in ambiente non persiano- lo approvino e ne illustrino vari casi. Mommsen avrebbe sostenuto che l'ebraismo dell'antichità sarebbe stato "fanaticamente propagandistico". Secondo Sand l'espansione dell'ebraismo sarebbe stata il risultato dell'incontro con la cultura ellenistica, nonostante il purismo ostile della storiografia nazionalista, e la monarchia degli Asmonei avrebbe basato il proprio sistema di potere su un monoteismo rigido e assoluto che ne rappresentò la specificità culturale e in cui sovrano e sommo sacerdote erano una sola persona. In questo contesto il rigetto dell'ellenismo si sarebbe rivelato effimero ed episodico. La rivolta dei Maccabei avrebbe espulso il paganesimo, non l'ellenismo, perché all'epoca non sarebbero stati disponibili né i mezzi né la consapevolezza per contrapporre la cultura ebraica a quella ellenizzante. Sand sottolinea come gli Asmonei avrebbero convertito -anche con la forza- gli abitanti delle terre conquistate; un dato che la storiografia ebraica avrebbe considerato con una certa difficoltà. La "simbiosi tra ebraismo ed ellenismo" avrebbe trasformato il monoteismo ebraico in una religione dinamica che sarebbe diventata uno degli attori in grado di spianare la strada al cristianesimo; in questo contesto Sand sottolinea l'iniziativa della traduzione dei Settanta -che diffuse i testi biblici fra le élite culturali del Mediterraneo- e l'inizio dell'ebraismo come religione multilinguistica, con il corrispondente allentamento degli antichi legami tra appartenenza linguistico-culturale e confini della fede. L'A. cita varie opere redatte in koinè e destinate a un proselitismo i cui frutti sarebbero stati notati con orgoglio dallo stesso Giuseppe Flavio. Sand trova plausibile che l'avvicinamento delle masse alla religione ebraica abbia portato a una completa conversione di centinaia di migliaia -se non di milioni- di individui nel Mediterraneo orientale, e di élite come quelle della Adiabene mesopotamica. Sand stima che con l'unità mediterranea sotto Roma nel III secolo la popolazione dell'impero avrebbe contato fra il sette e l'otto per cento di ebrei, soprattutto nella popolazione urbana, nonostante i romani a tratti mal tollerassero il loro monoteismo esclusivo e il loro proselitismo. La successiva crisi della cultura edonista e il serpeggiare della corruttela avrebbero indotto alla ricerca di sistemi giuridici rigidi e al rafforzamento del senso di appartenenza a una comunità; cose che l'ebraismo era in grado di offrire anche a molti semiconvertiti, detti timorati di Dio. La tendenza alla chiusura e l'avversione al proselitismo sarebbero maturate -pur nel permanere di molte posizioni intermedie- solo dopo l'ascesa del cristianesimo paolino, considerato gravemente eretico. Il suo affermarsi, dovuto tra l'altro alla riduzione dei precetti da osservare e alla immediata parità concordata ai neoconvertiti, avrebbe tolto attrattiva all'ebraismo cominciando a indebolirne i numeri. Sand ricorda che con Costantino il proselitismo ebraico sarebbe stato ostacolato per legge; setta insidiosa e riprovevole agli occhi dei cristiani, l'ebraismo sarebbe dovuto sopravvivere come "una sorta di anziana signora caduta in miseria [...] la cui esistenza da emarginata non faceva che dar ragione ai vincitori". Secondo Sand, dopo il IV secolo una politica identitaria con la formazione di comunità chiuse e sospettose verso i nuovi seguaci sarebbe stata la condizione necessaria per la sopravvivenza nel mondo cristiano; il proselitismo sarebbe però continuato ai confini estremi del mondo cristiano, con risultati anche significativi. La sfote diminuzione della presenza ebraica dal paese di origine, che dal I secolo i romani avrebbero chiamato Palestina, non sarebbe quindi dovuta ai pur ricorrenti eventi traumatici ma a una graduale conversione al cristianesimo comunque contrastata dalla solida presenza del giudaismo rabbinico babilonese. Contrariamente agli storici sionisti Sand ritiene che neppure la conquista araba, non fosse che per mera questione di numeri, avrebbe comportato l'avvio di una migrazione di massa. Anzi, a fronte delle ricorrenti persecuzioni bizantine gli ebrei avrebbero accolto di buon grado i conquistatori arabi e nonostante la scarsità di fonti Sand si dice convinto che le conversioni all'Islam non sarebbero mancate in un lento e prolungato processo di conversione che potrebbe dar conto della "scomparsa" della locale maggioranza ebraica molto meglio di quanto non faccia la storiografia tradizionalista. Con l'affermarsi del movimento sionista alcuni storici (Avraham Polak e altri) avrebbero sollevato proprio la questione della islamizzazione di massa, e contrariamente ai sostenitori dell'esodo avrebbero concluso che -conversioni nonostante- la continuità demografica della popolazione rurale si sarebbe mantenuta. La sopravvivenza di elementi linguistici e consuetudinari ebraici nella popolazione palestinese contemporanea avrebbe dovuto farla percepire come non dissimile da quella ebraica di cui si prospettava l'insediamento. Un pamphlet diffuso negli USA nel 1918 da Ben Gurion e Ben Zvi avrebbe fatto proprie queste conclusioni, e fino al massacro di Hebron del 1936 queste istanze conciliatrici avrebbero avuto buona visibilità nel movimento sionista. Dopo la rivolta palestinese gli abitanti locali sarebbero diventati agli occhi degli "agenti autorizzati della memoria" nient'altro che immigrati arabi giunti in massa nel XIX secolo in una terra quasi vuota su cui non potevano vantare diritti, e incentivati a restare proprio dallo sviluppo dell'economia agraria sionista. Nei programmi scolatici e finanche nelle formulazioni giuridiche i dati storici sarebbero stati sostituiti dalla mitologia nazionalista dell'esilio e del relativo ritorno: un popolo senza terra si sarebbe riappropriato di una terra senza popolo. Sand sottolinea come gli storici di professione fossero consapevoli dell'infondatezza di simili concetti e che avrebbero consapevolmente tollerato -se non incoraggiato- la diffusione di questa versione mitologica dei fatti, nascondendo e sminuendo al tempo stesso il ricordo delle conversioni di massa che avrebbe potuto danneggiare la narrazione della "solida unità biologica" del popolo ebraico.
Il periodo successivo è trattato nel quarto capitolo, dedicato "alla ricerca del tempo (ebraico) perduto". L'immagine dell'ebraismo come setta involuta e isolata, pur umiliante, sarebbe stata comunque accettata dalla storiografia sionista perché si prestava alla rappresentazione "etnica" di un popolo lontano dalla propria terra. Sand ricorda invece che l'ebraismo avrebbe continuato a fare proseliti in zone non ancora interessate dal monoteismo come la penisola arabica. Sand descrive le vicende del regno ebraico yemenita dello Himyar e la sopravvivenza di nuclei di popolazione ebraica nello Yemen fino al XX secolo, ricordando lo scarso interesse della storiografia sionista sull'argomento a causa del ruolo avutovi dal proselitismo. Tratta poi dell'ebraismo tardoantico nordafricano -anch'esso caratterizzato da quella rimarchevole espansione che solo il proselitismo poteva consentire- e sulla sua importanza nella cultura berbera e nell'opposizione berbera alla conquista araba. Anche in questo caso la storiografia sionista, scrive Sand, si sarebbe prodotta al meglio delle proprie possibilità per ridurre la portata del proselitismo e ascrivere il sussistere di comunità ebraiche nel nord Africa a maggioranza islamica alla schietta "discendenza abramitica". A mettere in dubbio la discendenza abramitica dei sefarditi avrebbe pensato il filologo Paul Wexler, propenso a considerare i sefarditi come discendenti di arabi, berberi ed europei convertitisi nel periodo compreso fra la formazione delle prime comunità ebraiche mediterranee e il XII secolo. L'uso dell'ebraico scritto che inizia a comparire col X secolo andrebbe inteso non come testimonianza di una continuità linguistica ma come una risposta alla canonizzazione del latino e dell'arabo per la cultura "alta" legata agli altri monoteismi. L'ebraismo in Spagna, frutto di proselitismo di epoca romana, sarebbe stato poi rafforzato dall'apporto berbero successivo alla conquista musulmana iniziata nel 711 e avrebbe prosperato in una società multireligiosa che spiccava in un mondo medievale caratterizzato da un monoteismo sempre più rigido e intollerante. Sand riferisce dei contatti tra emirato di Cordova e regno dei Cazari, documentati in modo relativamente attendibile nel X secolo, per iniziare a trattare una questione che i detrattori del proselitismo trovano più difficile da far passare sotto silenzio per motivi di convenienza. L'esistenza del regno dei Cazari fra il Volga e il Caucaso e la sua "sorprendente conversione all'ebraismo" sarebbero attestati da un buon numero di testimonianze di diversa provenienza e documentati in modo più dettagliato di qualsiasi precedente e meno duraturo regno biblico. Sand ipotizza, stanti le fonti disponibili, che la conversione dei Cazari sia avvenuta tra l'ottavo e il nono secolo, con un lungo e articolato percorso che vide anche l'arrivo di proseliti ebrei cacciati da luoghi in cui regnava uno dei monoteismi rivali, dall'Armenia all'Iraq. Questa conversione al giudaismo rabbinico avrebbe permesso il mantenimento dell'indipendenza a fronte di musulmani avversi al paganesimo e di cristiani bizantini che avrebbero imposto una qualche forma di asservimento, e consentito di consolidare e di accentrare un sistema di governo solido. Secondo l'A. i kagan cazari avrebbero instaurato "un modello monoteistico moderato e radicalmente diverso sia dalla temperie che caratterizzava la coeva civiltà cristiana e sia dall’êthos 'totalitario' della monarchia asmonaica"; la durata plurisecolare del regno avrebbe inoltre permesso all'ebraismo di diffondersi al di fuori delle élite, arrivando anche alle popolazioni confinanti. L'arrivo dell'Orda d'Oro e le estese distruzioni sofferte dal sistema agricolo cazaro avrebbero secondo Sand costretto la popolazione a emigrare in massa verso le odierne Polonia e Lituania. La storiografia degli Jost e dei Graetz, nota sarcastico, avrebbe provveduto a "rimuovere dal passato le colonne di proseliti che andarono a ingrossare le file del 'popolo prescelto'". Non così quella europea orientale, il cui interesse per una compagine statale stabile ed evoluta sarebbe stato ripreso da Dubnow, dagli storici sovietici e da Baron. Nel 1951 Avraham Polak avrebbe sostenuto in un saggio pubblicato a Tel Aviv l'origine cazara degli ebrei dell'Europa orientale; il suo lavoro avrebbe superato critiche serrate solo sottolineando il nocciolo "etnobiologico" ebraico del regno medioevale. Sand nota che nello stato sionista il tema dei Cazari non sarebbe stato praticamente oggetto di ulteriori approfondimenti dopo allora; un tema potenzialmente minaccioso per la legittimità dell'impresa sionista, o forse controproducente a fronte della crescente etnicizzazione della politica identitaria sionista che richiedeva margini e confini netti a fronte del contrasto con i palestinesi. Sand sottolinea come lo stato sionista avesse bisogno di "un popolo ebraico intero e indiviso" e che la sua edificazione dovesse essere compiuta "dai diretti discendenti della stirpe di Davide e non –Dio ce ne scampi– dai discendenti di rudi cavalieri delle steppe del Volga e del Don, dei deserti dell’Arabia meridionale o delle coste dell’Africa settentrionale". In Occidente il tema avrebbe invece ottenuto anche pubblicazioni divulgative: La tredicesima tribù di Arthur Koestler, uscito nel 1976, avrebbe levato nello stato sionista reazioni furibonde venendo tradotto in ebraico solo nel 1999. Sand riporta che la storiografia sionista riteneva invece che gli ebrei dell'Europa orientale fossero arrivati dalla Germania via Roma, come avrebbe attestato l'uso dello yiddish. Una tesi confutabile considerando la forte emigrazione tedesca verso est, che avrebbe portato alla formazione e alla diffusione di una lingua che in nessun modo avrebbe potuto formarsi nella Germania occidentale e che avrebbe invece molto in comune col tedesco sudorientale e col sorabo, e il numero molto ridotto di ebrei presenti all'epoca nel territorio tedesco. Sand scrive che nonostante molti ebrei dell'Europa orientale abbiano finito per rimuovere il proprio passato cazaro o slavo per ricordare solo "la propria uscita come schiavi dall'Egitto", gli indizi che attesterebbero la loro vera origine storica sarebbero molti, dalla toponomastica a una cultura popolare yiddish che è molto più somigliante a quelle vicine che non a quelle delle comunità ebraiche nordafricane o dell'Europa occidentale. Lo scarso interesse per la cultura yiddish e per i Cazari nello stato sionista di oggi secondo Sand non sarebbe casuale: la storiografia nazionale vi avrebbe avuto lo scopo essenziale non di indagare il passato ma di costruire "una metaidentità e una base politica per il presente". Ulteriori approfondimenti potrebbero secondo Sand rivelare come non sia mai esistito fra i seguaci dell'ebraismo un comune denominatore etnografico laico; l'ebraismo si configurerebbe quindi come una cultura religiosa e non come una "nazione" straniera ed errante. Il che significherebbe che non è neppure mai esistito un popolo maledetto per aver ucciso "l'unto del Signore" insediatosi a cose fatte come sgradito ospite nelle terre altrui.
Il libro si chiude con una trattazione sulla politica identitaria nello stato sionista. L'A. ricorda come il declino del proselitismo e la chiusura delle comunità ebraiche avessero rafforzato per secoli la fedeltà a una cultura condivisa fino ai profondi mutamenti comportati dalla modernità; l'epoca dei nazionalismi li avrebbe visti spesso antesignani o propugnatori convinti. Il sionismo sarebbe nato insieme alle ultime ondate di risveglio nazionalista in Europa e avrebbe costituito, al pari di essi, un tentativo di assimilazione collettiva alla modernità teorizzato da fondatori di cultura tedesca, diffuso e applicato da attivisti e intellettuali di cultura yiddish alle prese con l'ostilità degli altri nazionalismi. I pogrom del XIX secolo avrebbero incrementato una emigrazione verso Occidente già in corso, che sarebbe approdata verso paesi animati da un nazionalismo civico in grado di arginare l'inveterata diffidenza della tradizione cristiana; negli USA, in Inghilterra e in Francia un lungo processo non privo di grossi ostacoli avrebbe portato gli ebrei a diventare parte costitutiva del corpo della nazione. Laddove la costruzione del nazionalismo avrebbe avuto bisogno di forti discrimini e di robuste connotazioni identitarie l'ostilità sarebbe rimasta, e avrebbe portato il sionismo ad attingere a ingredienti dello stesso genere. Se il Bund socialista avrebbe provato a unire credenti ed ex credenti ebrei costruendo una cultura moderna e omogenea a partire dall'epoca contemporanea, gli intellettuali sionisti avrebbero invece cercato di cancellare alla radice le differenze etnografiche e di privilegiare un passato mitologico e religioso, puntellato con una fede escatologica. Fondere in uno unico éthnos gruppi linguistici e culturali diversissimi avrebbe richiesto il ricorso alla Bibbia come testo della "memoria nazionale" di un popolo formato da eterni esiliati, cancellando ogni riferimento al proselitismo e soprattutto ai suoi effetti. Sand sottolinea il carattere nazionalista ed etnocentrista del sionismo, che "circoscrisse rigidamente il popolo storico che aveva inventato" ricorrendo anche a criteri e concetti razziali. L'ereditarietà genetica avrebbe provveduto a legittimare le rivendicazioni sulla Palestina, l'antica Giudea non più centro sacro da cui sarebbe giunta la redenzione ma patria nazionale di tutti gli ebrei del mondo. L'A. ripercorre per sommi capi i contributi dati all'ideologia sionista da Moses Hess, Nathan Birnbaum, Theodor Herzl e Max Nordau -quest'ultimo proveniente da una solida esperienza saggistica in cui aveva cercato di "mettere in guardia il mondo dai pericoli dell'arte moderna, dell'omosessualità e delle malattie mentali, tutte espressioni di degenerazione razziale"- con una certa attenzione per le statuite peculiarità biologiche della costruenda nazione intesa poi da Martin Buber come comunità di sangue: Blutgemeinschaft. Aperti richiami al "sangue" e al "tipo fisico-razziale" in cui si fonderebbe il senso di consapevolezza nazionale sono netti in uno Zeev Jabotinski sicuro che in un prossimo futuro la scienza avrebbe definito un sistema di classificazione basato su "formule razziali". Arthur Ruppin, darwinista convinto, avrebbe rincarato adottando dopo i pogrom del 1929 in Palestina un atteggiamento eurocentrico già diffuso presso i medici sionisti e favorevole agli aschenaziti, un gruppo in cui meglio che negli altri si sarebbero conservati "caratteri eccezionali" da salvaguardare evitando innanzitutto i matrimoni misti. Nella Palestina mandataria Rippin avrebbe mantenuto rapporti accademici con l'eugenetica tedesca e curato gli acquisti di terre creando le istituzioni centrali per la loro ripartizione; la conquista di questi spazi -racconta Sand- sarebbe avvenuta senza interferenze con l'economia rurale palestinese: "l'unicità biologica doveva preservarsi attraverso una sistematica separazione 'etnica'". Questo isolazionismo nazionale non sarebbe servito a intenti suprematisti, ma a preservare una postulata identità avita che era il punto fondante per le pretese territoriali sioniste. Sand considera l'opera di Redcliffe Nathan Salaman -anch'egli medico- che avrebbe mostrato di considerare il sionismo una iniziativa eugenetica volta a migliorare la razza ebraica il cui tipo ideale sarebbe stato appunto quello aschenazita. La storiografia dello stato sionista presenterebbe una perdurante tendenza apologetica tesa a giustificare la presenza della "biologia" nella riflessione sionista in quanto elemento tipico della sensibilità dell'epoca, sorvolando invece su una nutrita schiera di detrattori da Ernest Renan a Karl Kautsky. Nei decenni successivi i principali lavori che disconfermavano approcci e prospettive contrari al sionismo biologico non avrebbero avuto diffusione nel dibattito accademico sionista e Sand è convinto che l'impianto dei Ruppin e dei Salaman abbia efficacemente impedito la diffusione di lavori che avrebbero potuto indebolire l'impianto ideologico dell'impresa sionista. Il tracollo postbellico delle prospettive che asserivano legami tra culture nazionali e biologia avrebbe eliminato l'espressione "razza ebraica" dal linguaggio scientifico; nello stato sionista si sarebbe parlato di una più rispettabile "ricerca sulle origini delle comunità ebraiche", ribattezzata "ricerca del gene ebraico" dal linguaggio comune. La pedagogia sionista avrebbe prodotto generazioni di studenti sinceramente convinti della unità "etnica" del proprio popolo: un concetto che la genetica scientifica avrebbe invece ampiamente disconfermato anche nei casi di ricerche appositamente addomesticate nella metodologia e nei risultati. Sand ripecorre piuttosto divertito l'accavallarsi degli studi genetici promossi dallo stato sionista e le contorsioni di una committenza intenzionatissima a dimostrare tutto e il contrario di tutto. I brillanti risultati conseguiti nella scoperta di un "gene sacerdotale" in oltre la metà di un campione di individui dal cognome Cohen avrebbero ad esempio sorvolato sul fatto che nulla garantiva che non potesse trattarsi di un "gene non ebraico". Secondo Sand nello stato sionista l'idea tradizionale della razza, "l’ombra lunga e minacciosa dell’idea di un popolo-razza eterno", di fatto continuerebbe a dirigere la ricerca genetica e la divulgazione dei suoi risultati. Sand ricorda che dopo la distruzione degli ebrei d'Europa i paesi ricchi avrebbero chiuso le porte ai superstiti, volentieri instradati verso una terra remota che non era la loro. Chi nel 1947 votò all'ONU per la fondazione di uno "Stato ebraico" e di uno "Stato arabo" in Palestina non avrebbe avuto a disposizione alcun discrimine valido al di là di quelli burocratici. La guerra del 1948 avrebbe cacciato o costretto alla fuga dal territorio dello stato sionista un numero di palestinesi più alto del totale degli ebrei allora presenti. In pratica, lo stato sionista avrebbe lavorato in favore di una comunità escludente che avrebbe affermato la propria autodeterminazione a spese altrui; lo stato sionista non sarebbe stato proprietà formale e reale di tutti i suoi cittadini perché fondato espressamente per il "popolo ebraico". Già nel 1947 l'affidamento al rabbinato del diritto matrimoniale avrebbe sovrinteso e tutelato questa specificità; non sarebbe stato l'unico caso in cui il potere statale avrebbe fatto ricorso a quello religioso per raggiungere i propri scopi. Sand specifica comunque che nello stato sionista si sarebbe sviluppata velocemente una cultura laica profondamente diversa dalle culture religiose, cui l'apporto dei non ebrei dello stato sionista sarebbe stato maggiore di quello degli ebrei del resto del mondo. Allo stesso modo non sarebbe mai esistita una cultura laica condivisa da tutti gli ebrei del mondo: la sovraidentità sionista sarebbe ancora oggi caratterizzata da una miscela di nazionalismo etnocentrico e di religione tradizionale diventata strumento nelle mani dei signori dello éthnos immaginato. Sand nota come anche la "Legge del Ritorno" di cui ripercorre storia e aggiustamenti non fosse fondata su principi umanitari, ma su una concezione del mondo nazionalista che imponeva l'esistenza di una base giuridica per l'idea che lo stato sionista appartenesse in fatto e in diritto agli ebrei di tutto il mondo. Dopo il 1967 nei territori occupati si sarebbe di fatto sviluppata una "democrazia dei padroni" ebraica sostenuta dallo stato; una situazione che avrebbe consolidato la consapevolezza del carattere etnocentrico dell'autorità. Sand considera anche il contemporaneo svilupparsi del separatismo etnico fra ceti popolari timorosi delle pretese di parità avanzate dai cittadini arabi dello stato sionista. Nel 1985 il pur modestissimo successo elettorale di una lista contraria al sionismo avrebbe indotto la Knesset a modificare la "Legge fondamentale del Parlamento" per escluderne a priori formazioni animate da intenzioni analoghe. Negli anni successivi una parte sempre crescente della destra storica si sarebbe trasformata "in una destra etnocentrica saldamente razzista"; il carattere di comunità escludente dello stato sionista sarebbe stato ribadito da leggi fondamentali su varie materie in cui esso veniva definito "Stato ebraico e democratico". Sand fa riferimento a un'indagine del sociologo Smooha per sottolineare come lo stato sionista non solo non si definisca come espressione della società civile presente sul suo territorio, ma si attende anche che i cittadini continuino a realizzare "gli scopi particolaristi" del sionismo. Lo stato sionista avrebbe reagito a critiche di questo genere mobilitando l'ambiente accademico in una difesa di un principio guida del tipo "separate but equal" e a un suo status morale postulato come elevatissimo e che Sand mostra invece ampiamente eccepibile. Nei testi redatti da esperti di diritto, nota l'A. che ne riporta vari esempi, si ha l'impressione che con "uguaglianza" i difensori dello stato sionista intendano piuttosto "indifferenza" e che l'eccezionalismo vi rappresenti comunque un postulato. "La debolezza dell’ideologia sionista di oggi", scrive Sand, "dipende dalla sua incapacità di riconoscere la complessità di una realtà in cui gli ebrei possono preoccuparsi del destino di altri ebrei senza per questo voler vivere con loro un'esistenza nazionale". Non tutti ambirebbero alla alyah; Sand nota che da anni il saldo della popolazione è negativo perché gli individui che lasciano lo stato sionista sono oggi più di quelli che vi si stabiliscono. Il nazionalismo ebraico e le garanzie a tutela dell'identità ebraica dello stato -come l'impossibilità di contrarre matrimoni civili- isolerebbero gran parte delle minoranze arrivando alla conseguenza paradossale di garantire eterno diritto di possesso dello Stato a un gruppo umano che a maggioranza non vive entro i suoi confini. Secondo Sand lo stato sionista rappresenterebbe un caso pressoché unico al mondo, in cui è la maggioranza a difendere la propria specificità e la propria identità grazie a una ingegnosa serie di misure legislative dalla "legge sui proprietari assenti" al diritto matrimoniale fino alle discriminazioni che colpiscono chi è escluso dal servizio militare. Sand considera lo stato sionista una "etnocrazia ebraica con tratti distintivi liberali" a servizio di uno éthnos biologico-religioso storicamente fittizio ma vitale, esclusivo e discriminante nella propria essenza politica. Dopo il 1967 il mito di uno éthnos ebraico inteso come corpo storico autonomo ed escludente sarebbe uscito molto rafforzato dalla prova sul terreno, traducendosi nella società sionista in una profonda ottusità verso la politica di dominazione attuata nei territori occupati. Di pari passo, nota Sand, lo stato sionista avrebbe smesso di fondare il proprio potere sulla demografia e avrebbe curato invece la fedeltà delle organizzazioni e delle comunità ebraiche della diaspora vicine ai centri di potere e di comunicazione del mondo occidentale. Sand avverte comunque come anche nella "diaspora transnazionale" la solidarietà con lo stato sionista non sia da considerare scontata, specie presso le nuove generazioni. Non sarebbe realistico attendersi che la maggioranza dello stato sionista smantelli il proprio stato come tale, conclude Sand. Sarebbe dovere di questa maggioranza, tuttavia, smettere di tenere in piedi "uno Stato segregazionista che esclude e discrimina una parte importante dei propri cittadini, considerandoli stranieri poco graditi". Il libro avrebbe cercato di dimostrare come sia stato possibile ridefinire in modo radicale un immaginario storico; Sand si chiede in conclusione se non sia possibile usare la stessa creatività per disegnare un futuro diverso.
Shlomo Sand - L'invenzione del popolo ebraico. Milano, Rizzoli 2010. 536 pp.
Shlomo Sand - L'invenzione del popolo ebraico
- Visite: 185
