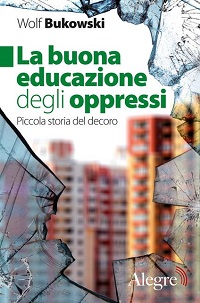
Wolf Bukowski è lo pseudonimo di un autore vicino al collettivo bolognese Wu Ming. Nel 2019 ha pubblicato questa piccola storia del decoro che illustra una lunga serie di casi concreti in cui la pretesa di una instaurazione o di un ripristino di condizioni decorose per la vita pubblica e associata non è servita ad altro che come copertura per un accanimento penale e amministrativo contro poveri, indesiderabili e non allineati in genere. Il discrimine essenziale perché determinate condotte vengano sanzionate resta difficile da identificare con precisione, ma si può sostenere con buona approssimazione che il grosso dei comportamenti sanzionati lo sia perché non contempla passaggi di denaro da chi ne ha poco verso chi ne ha molto.
Nel prologo è citato l'omicidio di Idy Diene, assassinato a freddo a Firenze da un Roberto Pirrone di cui l'A. ricorda la predilezione per l'igiene condominiale. Bukowski considera rilevante il fatto che negli ultimi anni le istanze dei pirrone siano uscite da quei pianerottoli in cui erano solitamente e giustamente oggetto di scherno, e si siano fatte "politica di parlamento" e terreno di una gara "a chi le interpreta con maggior rigore". Prova ne sarebbe il fatto che la prima, la più insistita e la successivamente più ripresa, diffusa e condivisa reazione del democratismo rappresentativo sarebbe stata quella di inveire per qualche vaso da fiori fracassato nel corso delle successive e immediate proteste di piazza. Il libro vorrebbe costituire quindi un tentativo di "perlustrare l'abisso in cui, nel nome del decoro e di una versione pervertita della sicurezza, ci sono fioriere che contano come, e forse più, delle vite umane".
Nel primo capitolo Bukowski cita il lavoro sulla lower class del politologo statunitense Edward Banfield e quello sulla underclass di Charles Murray, entrambi sostenitori del reaganismo e della distruzione dello stato sociale. Autori del genere avrebbero costruito una sociologia da bar che con il generoso sostegno di un think tank reazionario chiamato Manhattan Institute sarebbe stata "spedita fino ai pub del Regno Unito" ampiamente in tempo per influenzare il New Labour. Secondo Bukowski a questa pars destruens data dalla distruzione della riconoscibilità di classe dei poveri si sarebbe associata una pars construens data dal ricorso alla meritocrazia, intesa dalle persone serie come null'altro che la nuova denominazione del privilegio di nascita. Il neoliberismo compiuto, in cui una polarità ottimista e progressista ne completerebbe una rabbiosa e sovranista, addosserebbe quindi all'individuo ogni responsabilità per le sue condizioni. La selezione oculata del buon povero meritevole del welfare sfoltirebbe di molto la platea dei destinatari delle prestazioni, contribuendo a realizzare una visione del mondo che per simili contesti non concepisce altro che il taglio della spesa pubblica. Bukowski accenna a una politica di edilizia pubblica adottata nel 2019 in provincia di Parma in cui il mancato rispetto di una minuziosa serie di regole porterebbe a sanzioni fino alla revoca dell'alloggio, e alla poco meno recente introduzione, nell'ordinamento penale dello stato che occupa la penisola italiana, di misure suscettibili di sanzionare qualsiasi presenza fisica porti nocumento al decoro di un dato ambiente. Secondo l'A. a livello istituzionale la "meritocrazia" applicata ai contesti urbani difficili si tradurrebbe in mere operazioni di ripristino dello stesso decoro, il cui risultato altro non sarebbe che quello di alzare le quotazioni immobiliari della zona.
Dopo aver collegato meritocrazia e decoro nelle loro accezioni neoliberiste, Bukowski ricorda la "teoria delle finestre rotte" esposta per la prima volta dai reaganiani James Q. Wilson e George L. Kelling nel 1982. La teoria sosterrebbe che in tema di sicurezza urbana la percezione conta più dei fatti e che il modello di ordine pubblico da preferire sarebbe quello che soddisfa la percezione anche quando i fatti la contraddicono. Per non inimicarsi il voto di una middle class che negli USA decide i risultati elettorali sarebbe stato sufficiente usare le risorse disponibili per accanirsi contro illeciti minuscoli o persino inventati, anziché per perseguire crimini complessi a cominciare da quelli finanziari. Reprimere qualsiasi disordine, anche e soprattutto dalla personificazione rappresentata da "mendicanti, ubriachi e tossicodipendenti, adolescenti chiassosi, prostitute, vagabondi, mentalmente disturbati" placherebbe le ansie della middle class con costruttive ripercussioni sui risultati elettorali. Secondo Bukowski la teoria delle finestre rotte avrebbe conosciuto un successo tale da rendere superfluo motivare la repressione ricorrendo a una presunta proprietà transitiva tra disordine e crimine, e consentendo ottime carriere nel democratismo rappresentativo a individui capaci di rivendicare il diritto -e probabilmente anche il dovere- di prescindere dalla realtà. L'A. considera l'aspetto come un caso specifico di una pratica politica in cui si eviterebbero sistematicamente i dati reali, in cui si ragionerebbe sulla base di luoghi comuni e convinzioni diffuse per prediligere e rendere redditizio il mantenimento di un generalizzato clima di paura e di allarme sociale.
Il terzo capitolo ricorda le vicende relative alla "tolleranza zero" e alla sua nascita nella New York della fine del XX secolo per mano di William Bratton e dell'allora sindaco Giuliani. La New York della Quality of life Policing -tradotta operativamente grazie a un manuale chiamato "il breviario"- viene descritta come un luogo dove non pagare il biglietto in metropolitana, aprire una bottiglia di birra nel posto sbagliato o andare su una bicicletta priva di campanello sono comportamenti puniti con la detenzione. L'A. tiene a specificare che i comportamenti sanzionati sarebbero stati "quelli tipici e irrinunciabili dei soggetti che si intende criminalizzare"; chiunque non facesse già parte della gente disordinata ne sarebbe stato colpito solo "occasionalmente e collateralmente". Nel caso statunitense le sentenze di incostituzionalità che avevano reso inutili i provvedimenti più generici sarebbero servite proprio a descrivere nel dettaglio i comportamenti sanzionabili e a mantenere efficacia nella criminalizzazione degli indesiderabili.
La pretesa efficacia della tolleranza zero sarebbe smentita dai fatti. I reati sarebbero comunque stati in calo da anni in tutto il territorio statunitense, in probabile correlazione col calo nell'uso del crack e con il crescere del ricorso al delivery per lo smercio delle sostanze stupefacenti, tolte dalle strade ma non certo dal novero dei problemi. Il contrasto alle armi da fuoco a New York e il rispettivo calo di vittime, sottolinea Bukowski, si sarebbero dovuti non alla tolleranza zero ma alle iniziative del sindaco David Dinkins. Il merito sarebbero stato però arrogato da Giuliani, la cui dottrina si sarebbe difusa alimentando la paura, paura che avrebbe alimentato la diffusione delle armi che a loro volta avrebbero prodotto insicurezza vera -non percepita- "riproducendo così globalmente quella che è una vera e propria patologia sociale statunitense". Solo nel 2016 a New York si sarebbe ammessa la mancanza di prove empiriche di un rapporto tra repressione delle violazioni legate al disordine e andamento dei crimini gravi, sconfessando oltre vent'anni di tolleranza zero e di Quality of life Policing, cui la criminalità avrebbe anzi reagito con successo riorganizzandosi in modo da tenere presenti gli schemi di azione dell'apparato repressivo.
Il quinto capitolo tratta dell'espressione Quality of Life e del suo cambiamento di significato nel contesto newyorkese. A fronte del costo e dei tempi lunghi delle istanze sociali, inaffrontabili per un paese a postulata vocazione liberista, l'espressione sarebbe passata a comprendere le sole istanze securitarie. Il Manhattan Institute avrebbe contribuito alla definizione classista della qualità della vita; il suo collaboratore Fred Siegel avrebbe costruito nel 1992 una mitica genealogia della sofferenza delle classi povere, che l'A. presenta in termini biblici: il Paradiso della New York dei rimpiantissimi tempi andati sarebbe stato distrutto da una Eva impersonata dai movimenti per i diritti civili, colpevoli di aver consegnato la mela-città "alle minoranze, ai matti, ai poveri" che ne avrebbero lasciato solo il torsolo. Bukowski ricorda anche alcuni tratti essenziali dello scritto di Siegel perché sarebbero entrati nel canone del piagnisteo mediatico "occidentalista": una maglietta con una scritta sgradita diventa un "assalto sfacciato", i mucchi di rifiuti che fanno mulinello un "assalto estetico" e i venditori irregolari dei "predatori"; i lavavetri ai semafori vi verrebbro promossi ad "artisti del ricatto". Secondo Siegel la redenzione sarebbe arrivata solo quando i benestanti avrebbero deciso di prendere in mano la situazione cominciando con la cura di parchi cittadini lasciati a se stessi per ridurre le uscite dell'amministrazione. Curati da benestanti che hano "la cultura, la serenità e il tempo libero" indispensabili per dedicarvisi, i parchi sarebbero stati recintati per allontanarne i disordinati. Siegel, come un qualsiasi borgomastro nella penisola italiana di oggi, nega la legittimità politica di ogni voce dissenziente e ne censura i mezzi in nome della stessa dialettica che aveva reso impraticabile negando preventivamente il valore politico del dissenso. La seconda e più incisiva innovazione sarebbe stata rappresentata dai Business Improvement Districts, aree in cui "per il conseguimento del decoro a fini commerciali" vigilanza (ovvero allontanamento dei disordinati, non certo eseguito con metodi da ballo delle debuttanti), assistenza sociale e nettezza urbana sarebbero state gestite da privati. Con l'avanzare (sia soft che a suon di botte) della Quality of Life, a New York sarebbe arretrato il welfare: nel 1999 i posti letto negli ospedali pubblici sarebbero stati ridotti a un quindicesimo di quelli che erano nel 1972, i carcerati aumentati invece di sei volte. I disordinati, oltre centomila nel 2004, spinti ai margini della città.
Nel sesto capitolo Bukowski prende nuovamente spunto delle condizioni dei parchi newyorkesi per tornare al problema del finanziamento del welfare, dichiarato da Reagan in poi una realtà indiscutibile e sempre presentato come una urgenza del presente. Nella narrativa degli "sgravi fiscali" gli stessi vocaboli sarebbero una metafora: le tasse come afflizione, la loro eliminazione come atto eroico cui può essere ostile solo un malvagio. Una propaganda basata sull'appello alle emozioni forti e sulle semplificazioni estreme che sarebbe diventata la norma, aiutata dal generalizzato ricorso a un'operazione retorica per cui le conseguenze dei tagli di bilancio verrebbero presentate come una prova del fatto che è stato necessario procedere a quei tagli.
Affermando in continuazione che "non ci sono soldi" verrebbe contrabbandata l'idea che i rapporti sociali non siano modificabili e che il denaro non possa essere prelevato da dove si trova in abbondanza; i ricchi si terrebbero tutto, cedendo all'erario solo gli spiccioli necessari "affinché le masse siano culturalmente sedotte e, se non dovesse funzionare, militarmente represse". L'A. suggerisce di rovesciare il rapporto (se non il tavolo) sostituendo "non ci sono soldi" con "il welfare è irrinunciabile".
La seconda parte del libro illustra l'applicazione di quanto illustrato a vari casi specifici in Europa e nella penisola italiana. Nel settimo capitolo Bukowski considera come l'"impazzimento securitario" nella penisola italiana sia iniziato negli anni Novanta con l'inizio della immgrazione di massa ma senza che i dati sulla criminalità -quasi tutti in calo costante- ne forniscano spiegazione. Bukowski ricorda la perdita di ogni freno alla diffusione di concezioni basate sulla costruzione di comunità escludenti e sul rimpianto di un passato mitico, resa possibile dalla fine di ogni riferimento di classe nel discorso politico della sinistra; in esse la lettura dei conflitti sarebbe tra interni ed estranei alla comunità immaginata, tra civiltà e barbarie e per estensione tra decoro e degrado.
Bukowski ricorda come il securitarismo degli anni Novanta sia nato in un periodo di estesa desindacalizzazione e contrazione dei diritti e fa propria la distinzione di David Smail tra poteri distali irraggiungibili che prendono decisioni sostanziali e poteri prossimali alla vita quotidiana, cui la politica neoliberista tenderebbe ad addossare ogni responsabilità e la cui azione dipenderebbe però per intero dai poteri distali. "Se il mercato del lavoro è plasmato dalla precarietà posso far parte del team più affiatato del mondo, ma una volta giunto a scadenza il mio contratto non sarà egualmente rinnovato", scrive l'A. per illustrare la differenza. Enfatizzando paure e fastidi quotidiani, le agende grondanti sicurezza e degrado schermerebbero il riconoscimento dei poteri distali e faciliterebbero attribuzioni causali prive di risvolto sociale. L'ideologia neoliberista applicata alla quotidianità produrrebbe false spiegazioni e falsi nemici. Sul piano istituzionale l'enfasi sul potere dei borgomastri avrebbe avallato la loro elevazione a poteri prossimali, alla guida di enti locali economicamente svuotati e ipso facto costretti ad attuare le politiche più facili: la persecuzione di poveri, migranti e antagonisti per la messa a reddito integrale dei centri urbani, facilitata dall'assodata equivalenza tra inciviltà e insicurezza abituale per la "libera informazione". Dai primi anni del XXI secolo il ricorso al decoro avrebbe permesso di perseguire penalmente fattispecie fino a quel momento neppure previste come reati.
Secondo l'A. almeno dal 1994 a Milano la propaganda avrebbe iniziato ad amplificare ogni laio emesso da persone problematiche e "in preda ai propri fantasmi". Un certo numero di comitati cittadini molto coperti mediaticamente avrebbe iniziato ad attribuire i mali della città non alla diffusa corruttela, ma ai marginali, ai poveri e soprattutto a stranieri che "o sono criminali o assomigliano ai criminali". La loro ostentata "apoliticità" avrebbe coperto il veicolare gli interessi di commercianti e ceto medio; evitare di riconoscere questi interessi per quello che erano avrebbe contribuito a consolidare "l'eclissi della questione di classe nel discorso pubblico". Ironicamente la base di questi comitati sarebbe stata decimata non dagli immigrati, ma dai grandi centri commerciali promossi dalla classe politica da essi stessi sostenuta. A trarre vero profitto dalla sicurezza, invocando e ottenendo in pochi anni l'adozione di modelli newyorkesi, sarebbero stati gli industriali e i grandi possidenti.
Secondo Bukowski a Bologna il partito tradizionalmente egemone a livello locale si sarebbe limitato a recepire l'agenda dal neoliberismo dominante. E a tradurla nella promozione della repressione e nella rincorsa alle "più basse passioni forcaiole", adottando senza modifiche di rilievo la teoria delle finestre rotte e la sua traduzione operativa. L'A. considera più sincero James Q. Wilson, cui non piacevano quelli che alzavano lo sguardo dal disordine delle strade per additare il crimine economico e trasformare ogni discussione in un attacco all'ordine economico e politico che era una "bestemmia del sacro nome del capitalismo".
Alle spalle della politica bolognese Bukowski intravede la linea politica delle "città sicure", debitrice del left realism britannico e teoricamente fondata sulla sinergia tra prevenzione situazionale (telecamere, tornelli, sorveglianza...), prevenzione sociale affidata al welfare e prevenzione comunitaria affidata ai cittadini. All'atto pratico i "sindaci sceriffo" molto amati dalla "libera informazione" avrebbero implementato solo il primo dei tre elementi. La promozione di ricerche sulle necessità dei quartieri, secondo l'A., avrebbe dato il via a un circolo vizioso in cui il peggioramento del clima sociale si sarebbe alimentato dei contenuti mediatici in circolazione e del loro avallo indiretto da parte delle iniziative dell'amministrazione locale. L'A. ricorda il caso di residenti del quartiere modenese di San Faustino che avrebbero saputo di essere "in pericolo" leggendo stampa cittadina slegata dal reale. Nei casi meglio forniti economicamente si sarebbero premuniti con allarmi e serrature mostrandosi sospettosi di chiunque, nei casi intermedi avrebbero ancora messo i problemi nella giusta prospettiva, nei casi popolari avrebbero mostrato empatia e comprensione verso appartenenti alla stessa classe svantaggiati dal doversela vedere con una macchina statale e amministrativa e con un ambiente economico e sociale indifferenti se non ostili. Bukowski trova conferma all'idea che confondere e negare le istanze di classe sarebbe propedeutico a contrabbandare le necessità di sicurezza dei ricchi come necessità di sicurezza di tutti. Il "realismo di sinistra" sarebbe presto sfumato nel realismo capitalista di Mark Fisher -la sensazione diffusa che sarebbe impossibile anche solo immaginare un'alternativa coerente al capitalismo- allineandosi al "non ci sono alternative" dettato dal capitalismo.
Nella penisola italiana gli anni Zero avrebbero visto la sinistra spingere sull'acceleratore della sicurezza -per lo più identificata col contrasto all'immigrazione- e la destra raccoglierne i frutti elettorali, vincendo anche in realtà fino a quel momento precluse come la municipalità di Bologna. Gli esecutivi si sarebbero preoccupati di depenalizzare i reati da ricchi e da padroni per infierire sulla microcriminalità. a una "astratta sacralizzazione della vita" corrisponderebbe una pratica politica fondata su un "concreto disprezzo della condizione umana" diretto soprattutto contro le non-persone appartenenti a un numero sempre crescente di gruppi disumanizzati e sostanzialmente definiti dal plafond delle carte di credito. Un'alternanza politica di facciata e l'affermarsi del concetto di decoro avrebbero ripulito il quadro dalle istanze meno presentabili mettendo in chiaro che "è solo la proprietà a produrre la sacralizzazione": i consumatori di beni di lusso sarebbero stati difesi non solo dal fastidio di vedere i poveri, ma anche da quello di doversi confrontare con i meno ricchi. L'A. ricorda anche la criminalizzazione in blocco dei rom e dei rumeni (praticamente considerati una cosa sola) operata nel contesto delle elezioni amministrative romane del 2008. Per la prima volta dopo le leggi razziali del 1938 un gruppo definito con criteri etnici sarebbe stato indicato come elemento negativo per la convivenza civile. La legislazione a favore della "sicurezza urbana" introdotta nel 2008 sarebbe stata in parte dichiarata costituzionalmente illegittima tre anni dopo, quando l'avvenuta sedimentazione delle sue implicazioni avrebbe reso di fatto impossibile tornare indietro. Le amministrazioni locali ne avrebbero approfittato per emettere minuziose ordinanze persecutorie nei confronti dei disordinati -cioè dei marginali- perseguibili e perseguitabili semplicemente come tali anche grazie all'esteso diffondersi della delazione telematica. L'A. nota come in pochi anni il concetto di disordine si sarebbe esteso "al punto di generare sospetto verso chiunque non sia platealmente un benestante impegnato nei riti del consumo".
Il tredicesimo capitolo esamina l'ascesa del feticcio legalitario, in tutto dovuta a una sinistra che dopo aver abbandonato il concetto stesso di classe avrebbe caondidato e fatto eleggere qualsiasi imprenditore vagamente illuminato le si mostrasse disponibile. La discutibile condotta personale del Primo Ministro dell'epoca avrebbe consentito alla sinistra di opporgli una legalità implausibile a fronte di torme di avvocati, denaro e immunità parlamentare. La stessa che le pulsioni d'ordine ben radicate nella allora "opposizione" avrebbero invece diretto con successo contro le classi popolari alla minima manifestazione di disagio che andasse a toccare gli interessi sbagliati. Bukowski sottolinea come qualsiasi istanza uscirebbe deformata dall'esposizione al legalitarismo; ad esempio il ruolo redistributivo della tassazione lascerebbe ogni posto in agenda al pagare le tasse di per sé, la sinistra diventerebbe rappresentante non delle vittime del sistema economico, ma dei contribuenti irreprensibili. Unita alla lotta per il decoro, la legalità fiscale avrebbe aperto la caccia a chiunque fosse costretto a vivere di economia informale. Bukowski considera che la democrazia si sarebbe costruita per inclusioni successive, mantenendo un esterno come riserva di vita sociale cui far ricorso per non implodere. Esterno che comprenderebbe necessariamente anche l'illegale. Esorcizzare questo esterno e sottoporlo a un'applicazione inflessibile delle leggi non significherebbe solo reprimere i margini, ma soffocare il centro dell'esperienza democratica riducendola a un democratismo rappresentativo deputato all'organizzazione di "miseri affari".
Il quattordicesimo capitolo è concepito come un case study della festa bolognese del Venticinque Aprile, organizzata con grande successo di pubblico da individui e gruppi appartenenti all'esterno delle istituzioni. Il Venticinque Aprile al Pratello, scrive l'A., infastidisce una amministrazione cittadina legittimata solo dalla forza militare con cui fa rispettare la legge e che dell'esterno intenderebbe solo sbarazzarsi. L'A. insiste sugli aspetti più irritanti e ridicoli di una repressione attenta a che birra e urina non turbino il decoro e la sacralizzazione della vita astratta in esso implicita, e sul porre sempre nuovi e costosi vincoli agli organizzatori. Il facile vaticinio è che in pochi anni l'iniziativa finisca subappaltata a mescite a mangioteche della zona delegando al mercato il suo svuotamento, lasciando intatto un "ingessato e noioso" Venticinque Aprile istituzionale antistoricamente consacrato alla legalità invece che alla sconfitta del nazifascismo.
Il concetto chiave di decoro, sostiene l'A. nel capitolo seguente affrontando l'argomento con piglio derisorio, sarebbe tanto abusato quanto mal definito, e ancora peggio sovrapposto -se non equivalente- a quello di sicurezza. Citando Matteo Carrer, l'A. nota che il decoro potrebbe essere il trait d'union tra il diritto e la buona educazione, per cui i borgomastri avrebbero adesso la possibilità di sanzionare praticamente qualsiasi comportamento. Nonostante questo il concetto di decoro apparirebbe come indiscutibile, come innatamente presente in chi è chiamato a condividerlo e sarebbe anche dotato di una fondazione mitica ancorata ad altrettanto imprecisati bei tempi che furono. Molto spazio nel capitolo è riservata all'applicazione del concetto di decoro e delle sue implicazioni al tema dei graffiti e delle scritte sui muri. Dietro l'appello alla bellezza e allo wall painting da affidare ad "artisti di sicura competenza" l'A. vede solo l'intento di avocare il diritto di decidere anche sui muri e sul consegnarli a chi ne viene ritenuto legittimo titolare. Preferibilmente solvibile, se non proprio gentrificatore. Al tempo stesso troncando sul nascere a furia di daspo urbani e di multe a quattro zeri gli intenti di qualsiasi pioniere volesse tentare qualcosa di analogo. I lacerti del passato ridotti a reliquie (meglio se remunerative) sarebbero solo tollerati: la storia dell'avvenire sarebbe affidata solo agli sviluppi tecnologici partoriti dal capitale.
Il secondo esempio di traduzione operativa del concetto di decoro considerato da Bukowski sono le panchine antibivacco, costruite in modo che sia almeno impossibile sdraiarvisi. Alcune riflessioni sono dedicate al modello Camden bench, vertice della categoria. Nella penisola italiana le prime panchine antibivacco sarebbero state introdotte dalle Ferrovie dello Stato all'indomani della loro trasformazione in società per azioni e del loro spezzettamento in più aziende, accompagnato da una campagna propagandistica per cui l'avvento dei privati avrebbe assiomaticamente garantito servizi migliori e più economici. L'A. cita un dossier governativo del 2018 e un incluso "progetto gate" generosamente finanziato, allo scopo di trasformare le stazioni ferroviarie in "fortezze socialmente escludenti". L'A. si sofferma sulla retorica della "promessa mantenuta" con cui vengono propagandate iniziative securitarie: un modo per far passare un atto autoritativo come risposta a un'esigenza sociale espressa in un momento precedente. Solo che il momento precedente altro non sarebbe stato che quello dell'annuncio dell'atto autoritativo da parte di un candidato, che lo porta a compimento una volta eletto dopo avergli inventato un avallo di sacralità popolare.
La distruzione delle sale d'aspetto o la loro chiusura notturna avrebbe anche tolto ai viaggiatori un'occasione per riconoscere la propria comune umanità con gli esclusi, recidendo qualsiasi prossimità occasionale tra chi aderisce pienamente al processo capitalistico e chi ne è escluso, categoria che comprenderebbe anche i viaggiatori che non consumano abbastanza. Una separazione in base al censo diventerebbe abituale nelle pratiche tese ad attirare il turismo di qualità.
Nel diciottesimo capitolo Bukowski deride l'assunto per cui "la sicurezza non è né di destra né di sinistra" e il suo uso elettorale. L'A. considera decoro e sicurezza concetti di destra perché servirebbero a definire la platea dei civilizzati rispetto ai presunti barbari e verrebbero imposti con prassi altrettanto di destra, comprese tra la metafora militare, l'approccio aziendalista e il ricorso ai corpi speciali per il contrasto a illeciti di nessun conto. Bukowski nota anche che lo sfoggio di capi militari da parte di un protagonista del democratismo rappresentativo mediaticamente molto visibile altro non sarebbe a quel punto che la sanzione dell'indistinguibilità tra questioni di ordine pubblico, questioni militari e questioni politiche.
Il securitarismo contemplerebbe un attivo contrasto ai diritti civili, pressoché considerati concause dei delitti. Un atteggiamento che contemplerebbe anche un pragmatico disprezzo di qualsiasi spiegazione -derubricata a pretesto- che gli studi sociali possano dare della marginalità e del crimine. Bukowski ricorda come daspo e fogli di via comprimerebbero il diritto alla libertà di movimento, le ordinanze contro gli assembramenti il diritto di riunione, provvedimenti repressivi di ogni genere tutte le forme reali e non teatralizzate di opposizione politica. L'ambiente governativo si avvarrebbe abitualmente della prassi di non adeguare il riconoscimento dei diritti civili alle mutate condizioni sociali, ampliando il numero dei non-cittadini suscettibili di violenze istituzionali di ogni tipo.
All'attacco e allo svuotamento di senso dei diritti civili il securitarismo affiancherebbe il contrasto alle lotte sociali, con una organica repressione di un numero di comportamenti sempre più elevato accompagnata da operazioni mediatiche in grado di presentare ogni lotta sociale come crimine. L'A. ricorda come la decisione solo apparentemente tecnica di subordinare all'uso di una tessera l'apertura dei bidoni per la nettezza urbana abbia creato un'ulteriore categoria di disordinati da controllare, videosorvegliare, punire e additare alla pubblica esecrazione. Citando un lavoro di Enrico Gargiulo pubblicato nel 2015 l'A. nota come la depoliticizzazione di ogni istanza tenderebbe alla costruzione di una decorosissima "comunità a-conflittuale e passivamente fedele alle istituzioni" facendo diventare le proteste una questione individuale e privata, togliendo loro ogni avallo di tutela costituzionale come espressioni di libertà civile e facendone mera materia per la repressione. Lo svuotamento delle istanze sociali si avvarrebbe anche di forme di pseuodpartecipazione attiva ispirate alla open space technology e ai processi di facilitazione: in queste iniziative ogni questione seria e sostanziale verrebbe anestetizzata lasciando spazio e legittimazione a quanti dimostrino di desiderare "quello che le istituzioni desiderano che essi desiderino".
Bukowski cita infine come categoria tipica e riassuntiva tra quelle prese di mira dal decoro e dal securitarismo quella delle persone sofferenti di disturbi del comportamento, paradigma della patologicità intrinseca delle classi inferiori. Nella New York delle finestre rotte la deistituzionalizzazione non avrebbe rappresentato la premessa della costituzione di servizi territoriali per la salute mentale, ma la fine pura e semplice dell'assistenza. Nella penisola italiana si sarebbe pensato di far passare il trattamento del disagio sociale, esistenziale ed economico dalle mani dell'agonizzante welfare a quelle ferme e virili della gendarmeria. L'A. ricorda come il primo uso del taser nella penisola italiana "sia stato contro uno straniero, nudo, in preda a una crisi di agitazione e senza fissa dimora, nella decorosissima Firenze".
L'ultimo capitolo considera la messa a reddito del decoro -inteso come premessa per la gentrificazione commerciale- e gli operatori economici ad alto livello nei mercati immobiliari che ne trarrebbero vantaggio, indicati dall'A. come i vincitori del decoro, contrapposti agli ingannati del decoro chiamati a svolgere bassissima manovalanza, livorosa comunicazione sulle "reti sociali" e destinati a fare le spese dell'aumento del costo della vita ineluttabilmente correlato al decoro stesso. Nelle operazioni di "recupero" e "valorizzazione" il confine tra bello e brutto, ammissibile e non ammissibile, avrebbe almeno il pregio di seguire chiare linee di classe e di reddito; Bukowski chiude proponendo una sarcastica gerarchia di accesso alla città decorosa, ambiente in cui la perfezione coincide con la totale messa a reddito della vita urbana. Al più basso gradino i non consumatori non cittadini, ovvero i migranti poveri perennemente fuorilegge per un motivo o per l'altro in base a norme emesse apposta per bandirli. Poi i non consumatori cittadini soggetti a un pregiudizio meritocratico. Quindi l'ampia categoria dei consumatori cittadini suscettibili di retrocessione e di debita repressione appena mettono in atto comportamenti non statuiti come desiderabili. Al vertice della gerarchia il consumatore non cittadino, privo di necessità che non possano essere soddisfatte dal suo stesso denaro e politicamente utilizzabile per giustificare qualsiasi aggressione delle autorità nei confronti della vita urbana delle altre categorie.
Wolf Bukowski - La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro. Roma, Alegre 2019. 160pp.