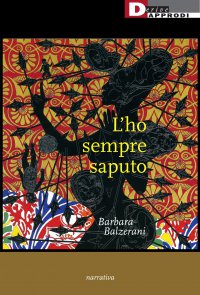
"Per niente interessata alle ortodossie, e altrettanto lontana dai pensieri deboli, dalle post teorie variamente declinate, dagli pseudo-pensieri salottieri radical, Barbara è sicuramente spiazzante, come capita agli spiriti liberi che non hanno padroni cui render conto".
Così Silvia de Bernardinis definisce Barbara Balzerani nella prefazione.
L'ho sempre saputo è un'opera in cui i cenni autobiografici, un certo elemento onirico e una storia di detenzione di pacifica verosomiglianza si mescolano continuamente nella narrazione in prima persona. Va da sé che chi intendesse cercarvi rivelazioni su un passato che non passa (e non passa perché esistono redazioni e buoni a nulla del democratismo rappresentativo fermamente decisi a non farlo passare) rimarrebbe deluso, neppure gli orizzonti temporali vi sono definiti con precisione. La parte maggiormente autobiografica del testo è il primo capitolo, La rivoluzione. La storia di una ragazza dai capelli lunghi e dal vestito corto negli anni Settanta del ventesimo secolo, dalle manifestazioni nelle piazze gremite al lungo epilogo di conventicole chiuse e rissose, ognuna convinta di essersi salvata dalla sconfitta altrui.
Ed è nel deserto neanche tanto metaforico che impone di trovare altre strade per continuare a lottare e a vivere che avviene, in carcere, l'incontro della narrante con Una donna africana con un fine pena lontano, tanto capace di muoversi nell'epoca contemporanea come di rifarsi a una conoscenza antica. Dai suoi racconti deriva la gran parte del testo per il secondo capitolo e per quelli successivi, in un continuo intrecciarsi di vicende umane e oniriche, antropologiche ed economiche. La gravidanza, l'inurbazione praticamente forzata, l'emigrazione, lo sradicamento che accompagna e che forse coincide con l'arrivo della modernità sono vicende individuali che aprono alla narrazione di vicissitudini collettive e di avvenimenti storici. Col progredire del testo la dimensione individuale dei racconti viene superata da quella sociale con i temi della modernità e delle sue storture e con quelli di un'epoca remota e senza padroni di cui l'autrice non cela comunque i limiti.
Così Silvia de Bernardinis definisce Barbara Balzerani nella prefazione.
L'ho sempre saputo è un'opera in cui i cenni autobiografici, un certo elemento onirico e una storia di detenzione di pacifica verosomiglianza si mescolano continuamente nella narrazione in prima persona. Va da sé che chi intendesse cercarvi rivelazioni su un passato che non passa (e non passa perché esistono redazioni e buoni a nulla del democratismo rappresentativo fermamente decisi a non farlo passare) rimarrebbe deluso, neppure gli orizzonti temporali vi sono definiti con precisione. La parte maggiormente autobiografica del testo è il primo capitolo, La rivoluzione. La storia di una ragazza dai capelli lunghi e dal vestito corto negli anni Settanta del ventesimo secolo, dalle manifestazioni nelle piazze gremite al lungo epilogo di conventicole chiuse e rissose, ognuna convinta di essersi salvata dalla sconfitta altrui.
Ed è nel deserto neanche tanto metaforico che impone di trovare altre strade per continuare a lottare e a vivere che avviene, in carcere, l'incontro della narrante con Una donna africana con un fine pena lontano, tanto capace di muoversi nell'epoca contemporanea come di rifarsi a una conoscenza antica. Dai suoi racconti deriva la gran parte del testo per il secondo capitolo e per quelli successivi, in un continuo intrecciarsi di vicende umane e oniriche, antropologiche ed economiche. La gravidanza, l'inurbazione praticamente forzata, l'emigrazione, lo sradicamento che accompagna e che forse coincide con l'arrivo della modernità sono vicende individuali che aprono alla narrazione di vicissitudini collettive e di avvenimenti storici. Col progredire del testo la dimensione individuale dei racconti viene superata da quella sociale con i temi della modernità e delle sue storture e con quelli di un'epoca remota e senza padroni di cui l'autrice non cela comunque i limiti.
Lo stesso succederà con la nascita della figlia: "i bambini non ragionano secondo i criteri dello scambio tramite denaro... Noi, all'opposto, crediamo che non esista legame se non attraverso il commercio di beni e così nascondiamo sotto l'aspetto economico la nostra concezione di vita." E a far uscire la narrazione dalle mura di una cella arriva la contrapposizione in Val di Susa fra la ferrovia ad alta velocità e il Gran Pertus che un uomo solo scavò in otto anni nella roccia viva per convogliare da una valle vicina l'acqua necessaria ai campi. Arriva la modernità con i suoi risvolti assurdi a fare strame della vita contadina materana. Arrivano le distruzioni del colonialismo a capovolgere in tutta fretta il mondo, dopo millenni, tra i Mapuche e a Rapa Nui.
Da questo panorama inizia il ritorno alla dimensione individuale del racconto, all'Africa dell'oggi, alle periferie, all'emigrazione, al parto in casa, ai debiti da pagare e ai viaggi da corriere.
Nel libro, si diceva, non esistono cenni precisi al passato che non passa.
Con una eccezione importante, nel primo capitolo.
"No, non eravamo soli. Anche i più miti fra gli adulti trovarono posto e ruolo, a volte determinanti. Come Caterina, per età più nonna che madre che quell'ultima sera aveva preparato la cena e aspettato inutilmente il ritorno di Roberto. Neanche un avviso, un estremo saluto dal compagno più amato, che era andato a farsi ammazzare in via Fracchia. Arrestata più di settant'anni, non s'era fatta intimidire, soprattutto da chi voleva rinnegasse i suoi ospiti che l'avevano certo raggirata e usata. Oltre al sangue, quegli uomini in divisa volevano anche il discredito dei corpi morti dei suoi compagni. È in fondo che le stavano chiedendo? Solo un pezzo di anima in cambio dell'impunità. Ma Caterina non sapeva che farsene di attenuanti patteggiamenti. Era fatta dell'impasto dei giganti e, forte come era delle sue ragioni e di un fiero senso di appartenenza cui non è da tutti arrivare, rimase salda sulle sue gambe che conoscevano la fatica di tutta una vita. L'eredità che ha lasciato è sfida aperta a chiunque pensi di mettersi in cammino sulla stessa strada: "ero brigatista prima ancora di entrare nell'organizzazione; ho la seconda elementare, quindi difficili ragionamenti politici non li so fare. Ma capire da che parte stare l'ho sempre saputo."
Barbara Balzerani - L'ho sempre saputo. DeriveApprodi, Roma 2017
Da questo panorama inizia il ritorno alla dimensione individuale del racconto, all'Africa dell'oggi, alle periferie, all'emigrazione, al parto in casa, ai debiti da pagare e ai viaggi da corriere.
Nel libro, si diceva, non esistono cenni precisi al passato che non passa.
Con una eccezione importante, nel primo capitolo.
"No, non eravamo soli. Anche i più miti fra gli adulti trovarono posto e ruolo, a volte determinanti. Come Caterina, per età più nonna che madre che quell'ultima sera aveva preparato la cena e aspettato inutilmente il ritorno di Roberto. Neanche un avviso, un estremo saluto dal compagno più amato, che era andato a farsi ammazzare in via Fracchia. Arrestata più di settant'anni, non s'era fatta intimidire, soprattutto da chi voleva rinnegasse i suoi ospiti che l'avevano certo raggirata e usata. Oltre al sangue, quegli uomini in divisa volevano anche il discredito dei corpi morti dei suoi compagni. È in fondo che le stavano chiedendo? Solo un pezzo di anima in cambio dell'impunità. Ma Caterina non sapeva che farsene di attenuanti patteggiamenti. Era fatta dell'impasto dei giganti e, forte come era delle sue ragioni e di un fiero senso di appartenenza cui non è da tutti arrivare, rimase salda sulle sue gambe che conoscevano la fatica di tutta una vita. L'eredità che ha lasciato è sfida aperta a chiunque pensi di mettersi in cammino sulla stessa strada: "ero brigatista prima ancora di entrare nell'organizzazione; ho la seconda elementare, quindi difficili ragionamenti politici non li so fare. Ma capire da che parte stare l'ho sempre saputo."
Barbara Balzerani - L'ho sempre saputo. DeriveApprodi, Roma 2017
